Stefano De Mari, un ammiraglio genovese per Filippo V
Negli anni della Guerra di Successione Spagnola, un ammiraglio genovese si distinse al servizio della marina di Filippo V: Stefano de Mari.
Sul finire del Cinquecento la Repubblica di Genova, ancora legata alle galee, aveva preso a noleggiare alcune delle moderne navi a vela. Col tempo le maestranze s’appropriarono delle nuove tecniche di costruzione e nel secolo successivo i cantieri alla Foce del Bisagno e lungo la Riviera di Ponente poterono varare numerose navi a vela di grande tonnellaggio. La politica ligure favorì la costruzione di vascelli mercantili di notevoli dimensioni e bene armati in modo che potessero fare a meno della protezione delle navi da guerra statali, i cui costi di gestione erano proibitivi. Tali navi venivano proposte al noleggio della Spagna per scortare la Flota de Indias nei suoi traffici oceanici soprattutto dai Doria. Così, navigando battendo la bandiera di altri stati in tempo di pace e valendosi della neutralità per navigare liberamente in tempo di guerra, Genova riuscì a ripensare sé stessa nel Settecento, destinando patriziato ed imprenditori marittimi all’asiento. In questo ambito comparve Stefano De Mari.
Nipote da parte di madre di Ippolito Centurione, famoso ammiraglio del Seicento, nonché discendente del condottiero omonimo che aveva partecipato alla Battaglia di Lepanto, Stefano De Mari, pur senza una diretta esperienza in campo marittimo o navale, si pose a capo di un gruppo di investitori che puntavano a far profitti sfruttando la difficile situazione che attanagliava la Spagna sul mare dopo il cambio della dinastia. Tutti gli sforzi fatti per ottenere il contratto fallirono, soprattutto per l’ostacolo posto dagli asientistas francesi, ma quando, dopo il Trattato di Utrecht, la Catalogna continuò a dirsi fedele a Carlo d’Asbrugo, De Mari riuscì ad avere la meglio sulla concorrenza francese ed ottenne di partecipare al blocco navale di Barcellona condotto dalla flotta di Andrés de Pes nell’agosto del 1713.
De Mari con tre navi di sua proprietà, un vascello di 70 cannoni ed altri due di portata inferiore, dette un contributo significativo alla flotta che impedì l’afflusso di rinforzi e di rifornimenti a Barcellona sino alla presa dell’11 settembre 1714.
Subito dopo Stefano de Mari si ritrovò ad accompagnare Elisabetta Farnese, seconda moglie del re Filippo V, nella traversata delle Alpi sino in Spagna, visto che la progettata navigazione da Genova ad Alicante era stata resa impossibile dal mal di mare che attanagliava la nuova regina iberica.
L’11 giugno 1715 un convoglio che conduceva ventiquattro battaglioni di fanteria, 1200 cavalli, 600 muli scortati da 18 navi da guerra e 6 galee al comando dell’ammiraglio Pedro de los Rios, fu inviato contro Maiorca. Stefano de Mari era partecipe della spedizione come comandante in seconda con tre vascelli di sua proprietà: El Real di 1000 tonnellate, con 65 cannoni e 360 uomini d’equipaggio, da lui stesso comandato, il Porcuspin di 550 tonnellate, 50 cannoni e 200 uomini d’equipaggio, ed il Principe de Asturias di 600 tonnellate, 50 cannoni e 280 uomini d’equipaggio. Tutto l’arcipelago delle Baleari fu recuperato senza difficoltà, ad eccezione di Minorca, ceduta alla Gran Bretagna con il Trattato di Utrecht. La lieta novella venne portata a Filippo V il 21 giugno ad Aranjuez, residenza reale poco distante da Madrid, dallo stesso De Mari che, per l’occasione, cessò d’essere un asentista e divenne a tutti gli effetti un ammiraglio della marina spagnola.
Fu un notevole successo per il genovese che da allora si mostrò fedelissimo a Madrid e protagonista d’ogni conflitto.
Il De Mari ricevette il comando di sei navi di linea, in unione a cinque galee comandate da Baltasar de Guevara, che salparono da Cadice nel luglio 1716 per andare in soccorso della fortezza veneziana di Corfù assediata dai turchi. La spedizione giunse presso l’isola quando i turchi si erano già reimbarcati. L’anno dopo la flotta fu rivolta contro la Sardegna, che era possesso di Carlo d’Asburgo e che Filippo V voleva recuperare. La squadra spagnola contava nove vascelli, sei fregate, due brulotti, due bombarde e tre galee; le navi erano ripartite in due divisioni, una agli ordini di Baltasar de Guevara e l’altra a quelli del comandante in capo Stefano de Mari, mentre le galee erano comandate da Francisco Grimau. Cagliari fu sottoposta ad un assedio e tutta l’isola fu occupata.
De Mari fu quindi mandato con la squadra verso Napoli che pareva essere il vero obbiettivo dei borbonici, tuttavia l’impresa fu fermata dalle pessime condizioni del mare e dei venti e l’anno dopo si orientò al recupero del Regno di Sicilia. De Mari era al comando di una delle divisioni della squadra di Antonio Gaztañeta y de Turribálzaga, forte di diciotto vascelli di linea, diciassette fregate, due brulotti, due bombarde e sette galee, scortando oltre trecento navi da trasporto. Tutta l’isola fu occupata ad eccezione della Cittadella di Messina che rimase in possesso dei Savoia.
Contro Filippo V si era intanto formata la Quadruplice Alleanza con Francia, Impero Austriaco, Gran Bretagna e Paesi Bassi e la flotta comparsa nel Mediterraneo diretta dall’ammiraglio George Byng contava numeri ben più alti di quella di Gaztañeta che preferì rifugiarsi a Malta. Però Byng si lanciò al suo inseguimento e, raggiunta a retroguardia al comando di De Mari, consistente di sei tra vascelli e fregate, delle galere, delle bombarde e dei brulotti, l’assalì tra Avola e il Capo Passero. Le navi di De Mari furono spinte verso terra ed El Real si arenò e fu presa. De Mari si salvò gettandosi in mare con molti ufficiali e marinai della sua nave. Byng passò poi al grosso del naviglio spagnolo che attaccò presso Capo Passero e annientò completamente.
Fu un disastro per la marina spagnola e questa sconfitta diede inizio al vero predominio marittimo inglese nel Mediterraneo in età contemporanea. Tutte le colpe della disfatta però caddero su Alberoni e la sua politica tesa a riportare in Italia Filippo V ed i figli avuti da Elisabetta Farnese.
Fu un disastro per la marina spagnola e questa sconfitta diede inizio al vero predominio marittimo inglese nel Mediterraneo in età contemporanea. Tutte le colpe della disfatta però caddero su Alberoni e la sua politica tesa a riportare in Italia Filippo V ed i figli avuti da Elisabetta Farnese.
Con la guerra che si avviava lentamente alla conclusione diplomatica, la figura del De Mari si eclissò dalle vicende belliche sebbene fu promosso Teniente general ed insignito dell’Ordine del Toson d’Oro, fu pure nominato Capitán comandante della compagnia dei guardiamarina. L’ammiraglio genovese tornò a solo nel 1727 quando Filippo V provò a recuperare Gibilterra. Per tutta la durata del conflitto le navi al comando di De Mari concorsero con le altre divisioni della flotta spagnola a mantenere libere le comunicazioni marittime, minacciate dalla superiorità delle flotte della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi. Fu però tutto inutile e, dopo due anni di combattimenti, il Trattato di Siviglia ribadì il possesso inglese di Gibilterra sebbene accettasse la successione dell’Infante di Spagna, Carlo di Borbone, al Ducato di Parma e Piacenza ed al Granducato di Toscana.
Stefano de Mari scortò in questo periodo il primo convoglio di diciotto bastimenti diretto nell’America spagnola, che salpò da Cadice l’8 agosto 1729 alla presenza del re e di tutta la corte, ritornando l’anno seguente con grandi ricchezze; nel 1731 fu promosso al rango supremo di Capitán General e gli fu affidato il comando della squadra di 25 navi da guerra, 7 galere e numerose unità da trasporto che condussero in Italia le truppe al seguito di Carlo di Borbone; nel 1737 entrò a far parte del Consiglio di Ammiragliato, costituito per assistere l’Infante Filippo nominato Almirante general de las fuerzas maritimas de España é Indias; l’ultimo incarico pubblico fu quello di ambasciatore di Spagna a Venezia, dove morì nel 1749.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: Paolo Giacomone Piana, L’ammiraglio Stefano De Mari; Guido Candiani, Navi per la nuova marina della Spagna borbonica: l’Asiento di Stefanto De Mari, 1713-1716



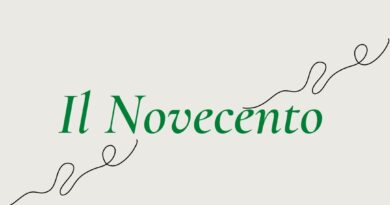
lo scorso anno la dott.ssa GIUSTINA OLGIATI mi ha chiesto i restaurare in documento dell’ARCHIVIO DI STATO di GENOVA , UNA PERGAMENNA DEL 1247, dove si citava l’AMMIRAGLIO GANDUS DE MARI , curiosa omonimia col ns. nome di famiglia , una antica tribu di ISTRAELE , citata anche su alcune mappe di un’antica bibbia olandese , il nome di battesimo penso sia dovuto ai contatti commerciali con miei avi , al tempo commercianti ( di pelli ? ) che vivevano in Spagna, forse a SIVIGLIA , avete notizie sui commerci dei DE Mari nel XIII SECOLO in Spagna?