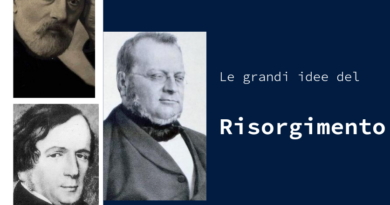Sistemi monetari preunitari: la forza economica delle monete locali
Sono largamente diffuse millantazioni su una superiore forza economica del Ducato Napoletano rispetto alla Lira Piemontese sulla base del fatto che il fino del primo è superiore, di oltre quattro volte (4,25 per la precisione), del secondo.
Urge precisare che valutare la “forza economica” di una moneta rispetto ad un’altra sulla base dei grammi di fino è una cosa stupida, oltre che priva di senso per il XIX secolo. Per le economie ottocentesche, infatti, l’unico tipo di confronto possibile è quello basato su due elementi, il numero di monete che un individuo riceveva come compenso per una prestazione lavorativa e cosa poteva acquistare con esse.
Secondo l’economista napoletano Antonio Scialoja, autore di Note e confronti dei bilanci del Regno di Napoli e Stati Sardi e Ministro del commercio nel 1848, nella seconda metà degli anni Cinquanta del XIX secolo, un maestro di scuola elementare nel Regno di Sardegna percepiva un salario annuo medio di circa 390 Lire annue, mentre un suo omologo napoletano, in un comune di terza classe, doveva accontentarsi di 50 Ducati.
Risulta, quindi, evidente come la quantità di argento ricevuto dal sabaudo sia superiore di oltre l’80% rispetto a quella ricevuta dal napoletano, ma possiamo ampliare il raffronto agli altri stati della Penisola. Grazie ad Edda Virgili Tucci, infatti, veniamo a conoscenza che nel 1852 un maestro elementare di Dolo, in Veneto, percepiva un salario annuo pari a 690 Lire Austriache, mentre Giuliano Friz ci fa sapere che nel 1858 a Montelibretti, nello Stato Pontificio, la retribuzione annua del maestro era di 88 Scudi annui. Risulta evidente che chi percepiva la quantità di argento maggiore è il maestro di Dolo, seguito dal pontificio, dal piemontese e poi dal napoletano, ma questa informazione non ci dice cosa i quattro potevano acquistare con il loro stipendio.
Secondo Giuseppe Felloni, nel 1856 il frumento si vendeva a 29,27 Lire Italiane per ettolitro sul mercato torinese, mentre Nunzio Federico Faraglia riporta un prezzo variabile tra 2,71 Ducati per tomolo nel 1852 e 3 Ducati nel 1860. Girolamo Secco Suardo, in Lo studio di Ferrara a tutto il secolo XV, saggio pubblicato nel 1894 nel IV volume degli Atti della deputazione provinciale di storia patria, ci informa che nel 1861 il prezzo medio di vendita del grano nel Bergamasco era di 20,64 Lire Italiane per ettolitro, mentre Alessandro Betocchi, autore nel 1874 di Forze produttive della Provincia di Napoli, che nello stesso anno nel comune di Casoria la farina di frumento si vendeva a 0,29 Lire il chilogrammo. Guido Pescosolido, poi, ci informa che nel quinquennio 1856/60 il prezzo medio del grano era di 20,64 Lire Italiane per ettolitro sul mercato romano, ed Andrea Gloria di 130,6 Lire Venete per moggio in quello padovano.
Il confronto tra le retribuzioni e questi valori ci dice che, pur in un contesto per tutti di “salari da fame”, il maestro elementare veneto poteva acquistare 31,89 ettolitri di cereale, il pontificio 22,68, il piemontese 13,32 mentre il napoletano, nonostante la maggiore “grossezza” della sua moneta doveva accontentarsi di soli 9,22. Questo è l’unico tipo di confronto sensato e un dato su cui vale la pena riflettere.
Nota Metrologica
Come ho già scritto, il Ducato Napoletano era tariffato a Lire 4,25, lo Scudo Pontificio invece a 5,32 e la Lira Austriaca a 0,87.
In Veneto, fino al 1860 circa, nel piccolo commercio i conti si tenevano in Lire Venete, ragguagliata in cifra tonda a 50 centesimi di Lira Italiana.
Nel Padovano gli aridi si vendevano a moggia da 347 litri cadauno, nel Napoletano a tomoli da 55,32 Litri.
Per convertire il valore del cereale da volume in litri a peso in kg è sufficiente ricordare che il peso ettolitrico medio del frumento è di circa 76 kg.
Autore articolo: Enrico Pizzo, classe ’74, residente sui Colli Euganei. Appassionato di storia veneta e storia dei sistemi monetari preunitari.
Fonte foto: dalla rete
Bibliografia: Andrea Gloria, “Il territorio Padovano Illustrato”, 1862; Angelo Martini, “Manuale di Metrologia”, 1883; A. Scialoja, “I bilanci del Regno di Napoli”, 1857; Giuliano Friz, “Burocrati e soldati dello Stato Pontificio (1800-1870)”, 1974; Giuseppe Felloni, “Scritti di storia economica”, 1998; Giuseppe Sacchetti, “Guido Pescosolido. Agricoltura e industria nell’Italia unita “, 2009; Nunzio Federico Faraglia, “Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860”, 1878; Vittorio Piva, “Manuale di Metrologia delle Tre Venezia e della Lombardia”, 1935