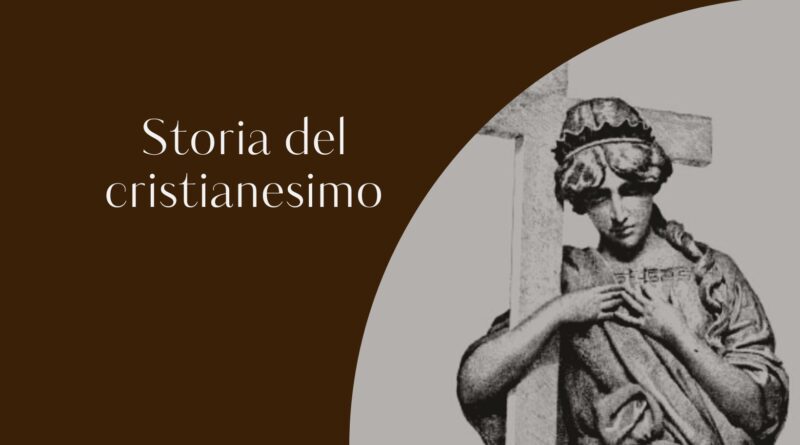Milano negli anni di Carlo e Federico Borromeo
Nipote di Papa Pio IV, Carlo Borromeo fu arcivescovo di Milano dal 1560. Aveva ventidue anni e grandi conoscenze di teologia e diritto. Solo alla morte del pontefice però lasciò Roma per raggiungere Milano. Era il 1565, s’era occupato del Concilio di Trento, era stato lui a spingere per l’abbandono dell’idea di riconciliazione con i protestanti ed aveva pure orientato il conclave all’elezione di Pio V, il papa di Lepanto. Ora si trovava in una città che poco conosceva ma a cui tanto diede.
A Milano, Carlo Borromeo disciplinò ordini e monasteri, patrocinò l’erezione di nuovi santuari e chiese, istituì il seminario, il Collegio di Brera e quello dei Nobili, fondò innumerevoli istituti di beneficenza, ma a fissarne la memoria nel cuore dei milanesi fu l’assistenza da lui coraggiosamente fornita agli appestati nel 1576. Assai noto è l’episodio della processione organizzata dal santo per chiedere l’intercessione affinché il morbo si placasse, fatta a piedi nudi, con in mano la reliquia del santo chiodo inserita in una croce lignea appositamente costruita. Incredibilmente, il morbo si placò e ciò fu interpretato da molti come una manifestazione della santità dell’arcivescovo.
Carlo Borromeo ebbe ovviamente parecchi nemici, soprattutto nel movimento degli Umiliati che, sospettati di calvinismo, ordirono contro di lui un attentato. In origine quest’ordine fornì alla cristianità grandi esempi di buoni costumi ma, arricchitosi, degenerò sino a divenire ostile ai pii rinnovamenti prospettati dal vescovo. Il diacono umiliato Gerolamo Donato, detto il Farina, con la promessa di quaranta scudi d’oro, s’introdusse nel palazzo arcivescovile e sparò un colpo di archibugio contro il religioso che fu mancato per miracolo. Il fatto è descritto in una lettera pubblicata nei “Documenti circa la vita e le gesta di S. Carlo Borromeo” di Aristide Sola: “Mercoledì sera, 26 ottobre, stando il signor cardinale Borromeo in cappella colla sua famiglia… gli fu sparata, vicino a quattro o cinque braccia, dall’uscio della cappella, un’archibugiata con palla e dadi di piombo; e la palla lo colse nel mezzo della schiena, e miracolosamente non gli fece male alcuno, ma solo gli segnò il rocchetto di nero, e lo macchiò tanto appunto, quanto si vede visibilmente la forma della palla. Fu colto ancora da un dado che gli passò il rocchetto e la sottana di ciambellotto, e altro male non gli fece: il che non si può attribuire ad alcuno mezzo umano, ma solo alla protezione che Dio particolarmente ha tenuto di lui… Ritiratosi in camera, si vide nella carne sua un poco di rossetto nel loco della percossa, senza però alcuna sorta di dolore, nè altro male”. L’attentato provocò una dura repressione. Farina e i suoi complici caddero in mano alla giustizia ed agli atroci metodi del suo secolo e l’ordine fu soppresso il 7 febbraio 1571, con una bolla di papa Pio V.
Lo seguì Gaspare Visconti che, sopraggiunta la morte dopo pochi anni di vescovato, seguì le opere assistenziali per malati e poveri di San Carlo Borromeo. Toccò poi a Federigo Borromeo, cugino di Carlo, creato cardinale da papa Sisto V il 18 dicembre 1587, che tenne la sede vescovile dal 1595 al 1631 e promosse la celebre Biblioteca Ambrosiana a partire dal 1609.
Di Federigo è esaltata la purezza degli intenti ed il grande amore caritatevole nei Promessi Sposi, ma il Manzoni si servì anche di una sua opera, il De Pestilentia, per descrivere la peste di Milano. In effetti il religioso vide la città ribellarsi alla guerra e spopolarsi per la peste. La fame, procurata dal conflitto e dai cattivi raccolti, portò al tumulto di San Martino, l’11 novembre del 1628, con l’assalto ai forni. Fu proprio Federico a guidare la processione di prelati che ristabilì l’ordine dopo la serrata dei panettieri.
Poi apparve la peste. Si usò allora il ricovero del Lazzaretto di Porta Orientale, si organizzarono disinfestazioni con fuoco e aceto, si murarono le case infette ed in parecchi furono soggetti a misure di quarantena, ma si permisero processioni e messe, persino il carnevale. Il morbo ovviamente dilagò: la popolazione passò da 130.000 abitanti a 66.000. Federico si prodigò con grande forza per soccorrere ammalati e moribondi ma, senza arginare gli assembramenti di gente, la peste tardò a svanire. La colpa si diede a misteriosi untori inviati da francesi e veneziani e furono giustiziati degli innocenti con tale accusa. Tra le vittime di queste atrocità ci furono il barbiere Gian Giacomo Mora ed il Commissario di Sanita, Guglielmo Piazza, giustiziati con il supplizio della ruota: a loro perpetua infamia fu pur eretta la “Colonna Infame” sulle macerie della distrutta casa del Mora.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Fonte foto: dalla rete
Bibliografia: A. Bosisio, Storia di Milano; AA.VV., Storia di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri; C. de’ Rosmini, Istoria di Milano