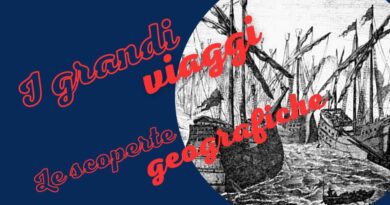L’honor Neapolis
Un grande taglio col passato si verificò a Napoli quando papa Analceto concesse l’honor Neapolis eiusque pertinentiarum a Ruggero II. Controvoglia Sergio VII dovette recarsi a Salerno, nel 1131, per compiere il suo atto di sottomissione al Normanno. Era la fine del ducato indipendente.
Il ducato di Napoli occupava un’ampia striscia litorale e comprendeva Ischia, Procida e Pozzuoli, raggiungendo Torre del Greco. Verso l’interno i confini erano piuttosto labili e, sotto la progressione dei normanni, ma già in precedenza sotto quella dei longobardi, i territori del Vesuviano e della vicina Liburia si configuravano come aree di confine in cui signori normanni esercitavano le loro prerogative e chiedevano tributi. Alcuni di questi territori vennero a lungo contesi. Per esempio, nel 1128, i napoletani avevano tentato di rientrare in possesso della contea di Suessola e di porre la Chiesa di Aversa sotto la tutela del loro arcivescovo, facendo pressione sui legati di papa Onorio II, ma le difficoltà politiche e militari di
Sergio VII erano evidenti impedimenti.
La bolla pontificia fu devastante per i ceti dirigenti di Napoli. Parlava di “honor”, non di ducato. Napoli era ridotta ad un riconoscimento onorifico, semplicemente “feudo di dignità”, un titolo nominale che non aveva precisa consistenza, temporaneità e vincoli ereditari. Questa sovranità non era stata ottenuta da Ruggero II come acquisì quella del resto del territorio dell’Italia meridionale, cioè per eredità o diritto di guerra. Il Normanno la ottenne per consacrazione papale nel 1130. E’ un dato curioso del quale va sottolineato anche il significato geopolitico: Napoli veniva affrancata da Bisanzio e consegnata pienamente all’orbita romana. Il glorioso ducato veniva assorbito in un regno nuovo e più grande sulla base di una dipendenza vassallatica che sottoponeva al re il magister militum neapolitanus.
Sergio accettò perché si vide impotente, ma non demorse dal tentare colpi di coda. Negli anni che seguirono Napoli divenne il centro di tutta la resistenza antirogeriana.
Nello scisma del mondo cristiano in seguito all’elezione di due papi dopo la morte di Onorio II, il clero napoletano parteggiò per Innocenzo II contro l’antipapa. Questa appartenenza e le sobillazioni dei mercanti pisani stanziati nella città fecero germogliare la rivolta contro Ruggero, supportata da Roberto di Capua, Rainulfo d’Alife e i beneventani. Nel 1134, tuttavia, venuti meno gli aiuti promessi da Pisa probabilmente per l’efficace opera della diplomazia di Ruggero II, Napoli e i suoi alleati, di fronte alle preponderanti forze rogeriane si spaccarono. Rainulfo si riconciliò col cognato, Roberto si rifugiò a Pisa.
Il duca di Napoli riuscì a conservare la sua dignità, il suo potere, ma il territorio del ducato si era ridotto ulteriormente, Ischia e Pozzuoli erano andate perse. Lo scadimento implicito nella trasformazione da ducato in honor, si palesò nelle sue forme più crude, ma Sergio non accettò tutto a lungo. Appena, infatti, si sparse la falsa notizia della morte di Ruggero, Roberto e Rainulfo si ritrovarono a Napoli, sostenuti dai pisani, per riprendere quanto perso. Sergio VII accolse nelle mura della città il conestabile di Benevento, Rolpotone, sperando che stavolta le cose sarebbero andate diversamente. Solo quando Ruggero prese Capua e poi Aversa, molestando le più prossime adiacenze di Napoli, volle piegarsi a giurare fedeltà. Ancora una volta, però, Sergio si ribellò.
Per tre anni, sostenuti da Innocenzo II e dal suo referente napoletano, l’arcivescovo Marino, i napoletani tentarono di sottrarsi a Ruggero II. Marino, Filippo di Acerra e Rainulfo incontrarono anche l’imperatore Lotario, nel 1137, per invitarlo a difendere Napoli. Con il Pactum Sergi rinnovo ed estese istituti, consuetudini e diritti preesistenti e consolidatisi nei secoli rafforzando i legami sociali della città. Ruggero la teneva sotto assedio, era incapace di avere ragione delle sue mura e della determinazione degli abitanti, ma le imponeva fame e sete. Tanti sacrifici della città ebbero giusto premio: il Normanno la dovette abbandonare, senza riuscire a vincerla, perché Roberto II aveva ripreso Capua e l’imperatore era entrato a Salerno. Neppure dopo la ripartenza di Lotario per la Germania, i napoletani rinunciarono alle loro pretese. Aspettarono prima che Ruggero espugnasse Nocera, ottenesse con forza tutta Terra di Lavoro e bruciasse Capua. Solo allora Sergio VII tornò definitivamente alla fedeltà regia.
In tutte queste angustie un “blocco granitico”, lo definisce Fuiano, si cementò tra il duca e i suoi fedeli, “un blocco che dava magnifica prova di sé in un’ora suprema… ma è un blocco granitico di forze, che non sorge soltanto da un reciproco vingolo affettivo fra il duca di Napoli e il suoi popolo o i suoi fideles oppure da un generoso e fervido amore di libertà, come dovrebbe dedursi dalla colorita e talvolta infiammata prosa del cronista beneventano. Mai forse come ora gl’interessi del duca coincidevano con gl’interessi dei suoi concittadini; forse questi ultimi, come si è già detto, avevano anche maggiore interesse di Sergio alla conservazione dell’indipendenza, all’accrescimento di potenza del loro piccolo Stato, tanto diminuito in quel torno di tempo e che proprio in quei giorni pareva mandare effettivamente gli ultimi bagliori. Si trattava naturalmente di interessi vivi e concreti di libertà o di privilegi cittadini, nei quali erano compendiati i risultati di conquiste lente e graduali, ottenute forse senza notevoli contrasti coi vari duchi di Napoli in più di un secolo e meglio definite di recente, almeno per quanto concerneva i rapporti della nobiltà con l’autorità ducale, nel già menzionato Pactum Sergi”. L’eroismo di Sergio però si scontrò con un senso di profonda sfiducia nell’esito finale della lotta. Dovette a un certo punto pensare che gli conveniva rinunziare a quella guerra ad oltranza e afferrare la buona occasione di un accordo con Ruggero. Il duca morì combattendo alla battaglia di Rignano Garganico: “Nato principe libero d indipendente di una città avvezza da secoli a riconoscere solo nella datazione una fittizia ed in realtà inesistente dipendenza da Bisanzio, egli moriva vassallo di un re al quale aveva per alcuni anni opposto la più strenua resistenza. Non era probabilmente un combattente animoso. Tuttavia la sua figura, meno appariscente di quella del valoroso Rainulfo e dell’instncabile principe di Capua, si snoda a tratti viva e drammatica fra le vicende di quegli anni eroici. Si trattò di un dramma silenzioso, sofferto nell’intimo della sua anima…”. E Napoli visse un definitivo asservimento alla monarchia normanna.
Opportunamente Galasso diede una analisi molto più profonda di quanto accaduto: “La concessione dell’honor Neapolis da parte d Anacleto II a Ruggero II nel 1130 esprime icasticamente l’addensarsi della tempesta, da cui la cinque o sei volte secolare autonomia e indipendenza del Ducato doveva essere travolta…. E’ noto quanto abbia fatto discutere il significato del termine honor in questo riconoscimento, fino al punto che uno studioso della competenza del Kehr non esitò a dichiarare che ‘è dubbio cosa significhino le parole honor Neapolis’. A nostro avviso è, comunque, anche dubbio che nella bolla di Anacleto quelle parole stiano a significare più che altro, come dice Cassandro ,e malgrado i suoi autorevoli riferimenti al Caspar e allo Chalandon, ‘una generica superioritas del duca su Napoli senza precisi contorni, senza la conseguenza di obbligazioni ben definite’. A noi sembra, cioè, che honor abbia nella fattispecie un più corposo significato, nel senso di un concreto e specifico titolo di sovranità da inquadrare sia nel complesso del rapporto feudale allora definito della Casa di Ruggero II con Roma, sia in quel contesto di sopravvivenza di alcune delle precedenti signorie e honores… In tale ipotesi la specificità di questo titolo di sovranità su Napoli si spiega più facilmente con l’ampliamento da esso implicato dei dominii di Ruggero II a un ambito nuovo e di grande rilievo anche storico. ‘Dopo la fine dell’Impero Romano non era mai stato possibile soggiogare Napli con la forza, avrebbe poi noitato l’Abate Telesino. L’appartenenza, quanto si voglia nominale e formale, della città e del Ducato all’area politica e alla sovranità bizantina non era mai venuta meno, come sappiamo, in linea di principio. Ora, invece, Anacleto tagliava questo vincolo semimillenario e legava Napoli a una sfera politica diversa, quella del Papato e dei potentati occidentali, e a una sovranità nuova, quella della nascente monarchia meridionale. Con la definizione di di honor non si introduceva, dunque, in alcun modo una più tenue consistenza del diritto riconosciuto così a Ruggero II sulla città…”.
Innegabilmente, tuttavia, Napoli visse una precipitosa decadenza politica. Fu spogliata di ogni ruolo, divenne dapprima una pertinenza di Capua, poi tramontava nel silenzio perdendo la sua millenaria importanza. La nobiltà che ne resse l’amministrazione, si consegnò ad Anfuso, principe di Capua, ed a Guglielmo, figli di Ruggero, che assunsero il titolo, ormai solo nominale, di duca. Tale titolo scomparve definitivamente quando Ruggero II nel settembre 1140 fece ingresso solenne nella città. Napoli divenne una città marginale del regno normanno: nel 1139, il diploma del legittimo pontefice Innocenzo II, addirittura non ne fece menzione, tanto meno venne citata nel concordato di Benevento del 1156.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: G. Galasso, L’eredità municipale del ducato di Napoli; M. Fuiano, Napoli nel Medioevo
(secolo XI-XIII)