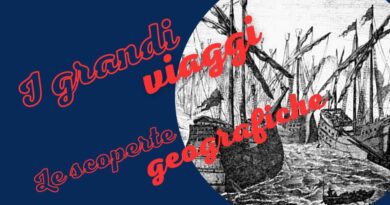L’eredità di Hernan Cortés tra Messico, Spagna e Italia
Nella storia l’intreccio di interessi dinastici e politiche familiari ha condotto su percorsi tortuosi ed inaspettati le discendenze di molti protagonisti di eventi cruciali, poi, l’esigenza di accrescere e trasmettere gli ingenti patrimoni ha creato nuovi legami familiari, fondanti sulla preminenza della convenienza economica, a cavallo degli stati e travalicando i secoli.
Il conquistador Hernan Cortés deve il nome con il quale è passato alla storia a ragioni squisitamente successorie, la famiglia d’origine, appartenente alla hidalguia dell’Estremadura, era quella dei de Monroy Pizarro, ma il padre Martin de Monroy antepose al proprio il cognome della madre, Maria Cortés, per poter a buon diritto subentrare nell’asse ereditario dei beni della famiglia materna. Sin dal 1648, un secolo dopo la conquista del Messico, un ramo della famiglia si stabilì in Sicilia, a seguito del matrimonio di Ferdinando de Monroy y Monroy con la baronessa Maria Francesca Perollo di Pandolfina, ottenendo nel breve volgere di un secolo numerosi possedimenti feudali, dall’elevazione in Principato della Baronia di Pandolfina, fino ad acquisire i titoli di Principi di Belmonte e di Maletto, Duchi di Giampilieri, oltre alla Signoria di Sciacca ed alla Baronia di Celso.
Il ramo che fiorì in Messico, dopo la conquista di Cortés, seguì le alterne fortune familiari legate ai tentativi dei discendenti del conquistador di rendere i propri possedimenti autonomi dalla corona spagnola. Nel 1529 il condottiero ottenne da Carlo V il titolo di Marchese della valle di Oaxaca, con una giurisdizione che si estendeva a gran parte del Messico centrale, nel quale gli successe dapprima il figlio Martin, che però si vide confiscare i propri beni in seguito ad un tentativo di ribellione che mirava a rendere indipendente il proprio Marchesato dal Viceregno della Nuova Spagna. In seguito il nipote Fernando, nel 1593, ottenne la piena reintegra nei possedimenti americani, ma morì privo di eredi diretti, cedendo il titolo ed i possedimenti messicani al fratello Don Pedro Cortés. Sul feudo centramericano, sin dalla sua costituzione, vigeva il diritto di maggiorascato alla famiglia Cortés, che ne riservava la successione ereditaria ai primogeniti maschi, ma ammettendo la possibilità di una successione femminile qualora non fossero sopravvissuti eredi maschili diretti dell’ultimo marchese né nipoti maschi, a condizione che il nome Cortés fosse mantenuto. Una condizione che si verificò nel 1629, alla morte di Pedro Cortés y Monroy, quarto Marchese della Valle di Oaxaca, che pose fine alla linea diretta del conquistador e generò la successione al Marchesato della sorella Juana, andata in sposa al Conte di Priego, Pedro Carillo de Mendoza. Da tale matrimonio nacque un’unica figlia, Stefania, che, aggiungendo ai nomi paterni il predicato Cortés, divenne la sesta Marchesa della Valle di Oaxaca, recando il titolo in dote al marito, il Duca Diego Aragona Tagliavia di Terranova, nobile palermitano che fu comandante della cavalleria del Regno di Sicilia e diplomatico in Francia e nelle Fiandre, sotto i monarchi spagnoli Filippo III e Filippo IV d’Asburgo. Diego Aragona dovette anche difendere in una complessa disputa giudiziaria, avviata dal Marchese Luis Carrillo, la propria successione al Marchesato di Oaxaca, che gli fu confermata nel 1635 da Filippo II.
Dopo questa unione la discendenza dei Cortés si radicò definitivamente in Sicilia, con l’unica figlia della coppia che assunse il nome di Giovanna Aragona Tagliavia Cortés e divenne una delle ereditiere più ricche ed ambite del suo tempo. Il 16 giugno 1639 sposò a Palermo il Principe Ettore Pignatelli di Noia, Duca di Monteleone e Grande di Spagna, dando seguito ai capitoli matrimoniali sottoscritti un anno prima sotto l’egida del Cardinale Giannettino Doria, Viceré di Sicilia, che prevedevano che il nome del nuovo casato sarebbe stato Aragona Pignatelli Cortés, e che esso avrebbe riunito un vastissimo patrimonio feudale all’interno dei possedimenti spagnoli, comprendendo qual che restava dei territori messicani, vasti possedimenti tra Calabria e Basilicata del Principato di Noia, i feudi dei Tagliavia e gran parte della Sicilia meridionale con il Principato di Castelvetrano, il Ducato di Terranova ed il Marchesato di Avola. Oltre all’immenso patrimonio ed alle rendite dei possedimenti d’oltremare, si formò progressivamente in Sicilia anche il grande archivio Cortés, che condensava una enorme documentazione sulle vicende del Messico e sui rapporti tra le nuove strutture del potere coloniale e la corona spagnola, tra il XVIII ed il XIX secolo. Questa immensa e preziosa mole di documenti, fusa nei secoli con le carte private della famiglia, è stata acquisita negli anni ’30 dall’Archivio di Stato di Napoli.
I vasti possedimenti in terra americana furono mantenuti anche dopo l’indipendenza del Messico nel 1821, amministrati dal politico e scrittore Lucas Ignacio Alamàn che mantenne i legami economici tra le tenute agrarie e gli interessi dei Pignatelli in Italia meridionale, un legame che fu progressivamente spezzato dalla metà del XIX secolo, dapprima con la riforma agraria del 1856, ed in seguito con la legislazione liberale del presidente Porfirio Diaz, volta a favorire la circolazione della proprietà terriera. Gli eredi Cortés vendettero la quasi totalità delle loro proprietà negli ex feudi messicani, conservando unicamente i titoli nobiliari relativi, tra i quali, oltre al Marchesato di Oaxaca, quelli di Signore di Tuxilla, di Coyocan, Cuernavaca ed Etla. Le residue proprietà immobiliari della famiglia, in quanto italiana, furono confiscate dal governo messicano nel 1942, dopo l’entrata in guerra del Messico contro l’Italia.
In Italia, durante il periodo risorgimentale, la famiglia aderì alle tendenze liberali e, nel 1871, Diego Pignatelli d’Aragona Cortés Lucchesi-Palli fu nominato senatore del regno, questi, figlio del XIV Marchese della Valle di Oaxaca, Giuseppe Pignatelli, tentò, senza successo, di vedersi riconosciuto il titolo dal Regno di Spagna, che aveva dichiarato vacante il marchesato dal 1872. Trascorsi svariati anni senza che nessun pretendente fosse stato in grado di dimostrare i propri diritti di successione, Alfonso XII dichiarò soppresso il titolo marchionale nel 1885. Morto senza eredi il principe Diego Pignatelli, il titolo di Marchese della Valle di Oaxaca fu reclamato dal nipote Giuseppe Pignatelli d’Aragona Cortés Fardella, Principe di Castelvetrano, anch’egli membro del Senato del Regno d’Italia, figlio del fratello Antonio e di Donna Marianna Fardella, che ottenne nell’aprile del 1916 il parere favorevole alla successione dalla Diputación de la Grandeza di Spagna, un successivo decreto del Re Alfonso XIII ripristinò il titolo e gliene riconobbe il possesso. Il XV marchese morì nel 1938, durante la Guerra Civile Spagnola ed in periodo repubblicano, pertanto suo figlio Antonio avanzò una richiesta di successione solo nel 1951, dopo che il governo franchista aveva formalmente restaurato la monarchia spagnola e gli organi di diritto nobiliare, ma non integrò mai tutta la documentazione richiesta dalla Diputación de la Grandeza, venendo dichiarato rinunciatario. Un ultimo tentativo di riportare il titolo in Italia fu compiuto nel 1972 dal Principe Diego Pignatelli, che, però, non fu in grado di raccogliere tutti i documenti necessari, rinunciando dopo breve alla sua pretesa.
Dopo il 1975 il titolo di Marchese, assieme al Grandato di Spagna, fu riconosciuto a Jorge de Llanza y Bobadilla, nobile spagnolo lontano discendente di Diego Pignatelli Aragona Cortés, che fu Marchese della Valle di Oaxaca nel XVIII secolo, ponendo così termine, dopo quattro secoli, alla linea italiana della dinastia che aveva creato il nucleo originario del Messico coloniale. Tra le magnifiche memorie di quel passato, sono ancora visibili il barocco palazzo Tagliavia-Aragona Pignatelli di Castelvetrano e la grande villa Pignatelli di Napoli, che ospita le collezioni del museo intitolato al Principe Diego Aragona Cortés.
Autore articolo: Salvatore De Chiara
Bibliografia: Dizionario Biografico degli Italiani Treccani; José Ignacio Conde y Díaz-Rubín, Javier Sanchiz Ruiz, Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias en Nueva España y México; Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Vol. X; www.pignatelli.org.
Salvatore de Chiara, giornalista, cultore di storia militare e collezionista di cimeli bellici. E’ curatore del Civico Museo di Storia Militare di Aversa e membro del comitato scientifico del MOA (Museum of Operation Avalanche) di Eboli.