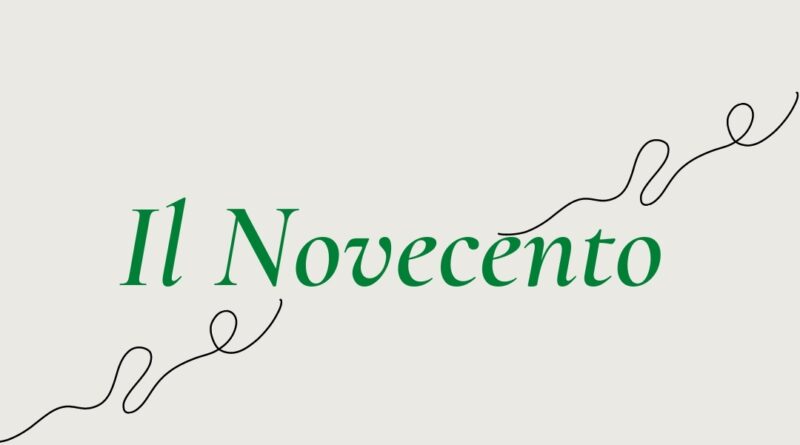L’economia italiana negli anni della Ricostruzione
Gli anni che seguirono la fine del secondo conflitto mondiale costituirono per l’Italia il cosiddetto periodo della Ricostruzione (1945-1955). E’ questa una denominazione impropria perchè gli eventi di quegli anni andarono assai al di là della restaurazione materiale della capacità produttiva nazionale distrutta dagli eventi bellici.
Il Paese si trovò a dover affrontare problemi di estrema gravità, ovvero la ricostruzione delle attrezzature produttive, l’inflazione impazzita e la strozztura della bilancia dei pagamenti che impediva acquisti di materie prime, ma nel lungo periodo il problema di fondo era quello storico di una disoccupazione strutturale che portava con sé l’esigenza di rilanciare lo sviluppo industriale e dare una soluzione all’arretratezza del settore agricolo.
Si discusse della conservazione del sistema di razionamento dei generi alimentari, della permanenza del controllo sulla disponibilità di valute estere, dell’introduzione di un’imposta patrimonaile. Ogni proposta toccava questioni rilevanti di politica economia. Il razionamento dei generi alimentari, infatti, avrebbe permesso di far fronte alla scarsità di generi essenziali, controllare le assegnazioni di valuta estera significava avere la possibilità di concentrare le importazioni nei settori di maggiore interesse per la ricostruzione e l’imposta straordinaria sul patrimonio avrebbe avuto lo scopo di eliminare i sovrapprofitti degli speculatori ed attenuare l’estrema concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi delle regioni meridionali. Figure atutorevoli come Einaudi, Bresciani Turroni, Fanno, Del Vecchio, Demaria e Corbino concordavano nell’identificare tali scelte con i principi autoritari del fascismo e preferivano un ritorno al principio della libertà di scambi come coronamento della restaurazione democratica. In effetti la discussione sui principi generali di gestione economica del Paese vide emergere proprio l’idea di abbandonare progressivamente la politica di protezionismo e di chiusura degli scambi con l’estero, in favore di un’economia aperta.
Tradizionalmente carente di materie prime, l’Italia avrebbe anzitutto dovuto assicurarsi lo sviluppo delle importazioni per garantire le materie prime estere necessarie al rilancio industriale. A sua volta, lo sviluppo delle importazioni esigeva però uno sviluppo parallelo delle esportazioni. L’Italia si orientò quindi verso una rapida liberalizzazione, integrandosi nell’economia europea. Alla fine del 1946 era stata ammessa al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, nel 1949 all’Oece, nel 1950 all’Unione europea dei pagamenti, nel 1953 alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. La tappa finale di questo processo fu raggiunta nel 1957 con la stipulazione del Trattato di Roma che diede origine al Mercato Comune Europeo.
Il governo Parri pose in primo piano la decisione di effettuare il cambio della moneta come misura di lotta all’inflazione e di rastrellamento dei profitti speculativi. Le cose cambiarono col governo De Gasperi e la sconfitta delle sinistre che aprì ad una politica di abolizione graduale dei controlli, a cominciare da quello del corso dei cambi. Venne concesso agli esportatori un premio di esportazione di 125 lire per ogni dollaro, poi si concesse loro la libera disponibilità del 50% della valuta ricavata dalle esportazioni. Venne poi lanciato un prestito pubblico, detto della Ricostruzione, per coprire la spesa pubblica, ma, al fine di assicuarne la sottoscrizione, fu necessario incoraggiare l’intervento delle abcnhe che ottennero così ammontari cospicui di liquidità dalla Banca d’Italia, e alla fine ciò generò un’immissione di liquidità fresca nel circuito monetario. L’inflazione allora riprese vorticosa. Nel 1947, al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, De Gasperi aprì una crisi di governo escludendo definitivamente il PCI ed orientando la politica economica ad eliminare i prezzi politici ed a stabilizzare il corso del cambio. La manovra bloccò l’inflazione, ma generò anche una stretta creditizia che provocò una caduta degli investimenti fino alla metà del 1950.
Per quel che concerne il Sud, le condizioni precarie dell’agricoltura, caratterizzate da una pressione demografica eccessiva rispetto alla povertà delle risorse e dalla carenza di attività produttive moderne, generarono la ribellione dei contadini contro la grande proprietà. L’unica misura presa, nel 1944, col decreto Gullo, autorizzò l’assegnazione ai contadini delle terre lasciate incolte dai proprietari, ma ciò ebbe un’applicazione limitata. Per il resto i movimenti furono schiacciati dalla repressione. Nuove occupazioni di terra, fino agli anni Cinquanta, imposero un più chiaro intervento per incoraggiare la nascita di un’ampia politica di opere pubbliche. La riforma fondiaria, invece, fu approvata in tre tempi: la legge Sila del 12 maggio 1950, la legge stralcio del 21 ottobre 1950 e la legge della Regione Sicilia del 31 dicembre 1950. Furono assoggettati a esproprio i terreni posseduto in eccedenza al valore imponibile di lire 30.000. Tali terreni furono assegnati a famiglie contadine in modo da assicurare ad ogni unità familiare un livello di reddito accettabile. La Cassa per il Mezzogiorno, sorta con la legge 646 del 10 agosto del 1950, poi, si assunse l’onere di realizzare investimenti fondiari, nonché le opere pubbliche.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: A. Graziani, Lo sviluppo dell’economia italiana