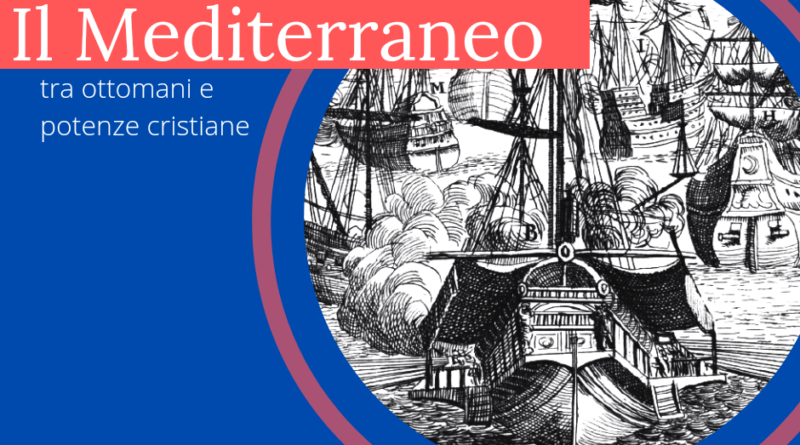Le repubbliche marinare nel Vicino Oriente
Dopo l’anno Mille, sempre più numerose furono le navi delle repubbliche marinare nell’Ellesponto e sorsero le prime colonie commerciali. Sembra accertato che i primi italiani a stabilirsi per ragioni commerciali furono gli amalfitani. Furono qui presenti già prima dell’anno mille, in verità, perché in una bolla d’oro di Alessio Comneno, risalente al 1082, si trova già menzione di numerose botteghe lì possedute da gente di Amalfi. Verso il 1200 esisteva a Costantinopoli un intero quartiere amalfitano, uno scalo marittimo, tre conventi e numerose case. Il più autorevole degli amalfitani del posto era un certo Pantaleone che possedeva case e fondaci non solo a Costantinopoli ma anche in altri porti del Mar Egeo. Sicuramente Amalfi contò all’epoca colonie commerciali anche in Siria e Palestina prima delle crociate e, in seguito alla partecipazione a queste, ottenne un terreno proprio a Gerusalemme e altre concessioni ad Antiochia, Accone, Tripoli di Soria e Cipro. Un “Porto Malfitan” è pure segnato nelle vicinanze di Sebastopoli sulle carte antiche. La decadenza di questa colonia seguì quella di Amalfi, battuta dai pisani.
Erano destinati a seguire la stessa sorte degli amalfitani, combattendo tra genovesi e veneziani, infatti una delle prime menzioni delle attività dei pisani a Costantinopoli ci parla dell’assalto da essi dato, nel 1162, al fondaco dei genovesi, saccheggiato e distrutto. I pisani presero pure parte alle crociate e si impossessarono nel 1099 delle isole di Santa Maura e Cefalonia, ebbero altri privilegi dai bizantini, uno scalo, un quartiere, il diritto di commerciare in tutto l’impero e di non pagare se non il quattro per cento sulle merci che vi introducevano, oltre all’esenzione totale del dazio, un proprio spazio a Santa Sofia ed uno all’Ippodromo. Il Vicus Pisanorum si estendeva sul Corno d’Oro e comprendeva case, due chiese, un convento, un ospedale. A reggere la colonia c’erano un comes ed un vice comes.
Bisogna precisare che la prima crociata portò i cristiani in Terra Santa essenzialmente via terra, tuttavia, non appena fu presa Gerusalemme, divenne evidente la necessità di stabilire un controllo permanente sulle coste del Levante. Fu a quel punto che si sentì l’urgenza di attrezzare una imponente flotta che potesse garantire il concorso via mare in caso di assedio o in caso di difesa. Il problema era serio. Buona parte dei protagonisti di quella crociata era costituita da signori terrieri franchi e nessuno di essi era in grado di assumere immediate iniziative in mare. Nell’era della vela, la progettazione, la costruzione e la gestione di imbarcazioni per la navigazione marittima richiedevano conoscenze e competenze altamente specializzate, tantomeno si poteva pensare ad un modo semplice e veloce per trasformare un soldato in un marinaio o un cavaliere in un ufficiale di marina. Occorreva necessariamente rivolgersi a marinai cristiani professionisti.
L’impiego, nel dicembre 1099, della flotta pisana non garantì Giaffa ai franchi e, passata la Pasqua, i pisani rientrarono. Furono allora chiamati a partecipare i veneziani con circa duecento navi. Questo accordo garantiva a Venezia una chiesa, un magazzino ed un terzo del bottino di qualsiasi città catturata dai franchi in Terra Santa. Doveva persino garantire l’intera città di Tripoli, se solo fosse stata conquistata entro il mese di agosto. Fu conquistata Caifa ma non Tripoli.
Con una flotta genovese, nel 1101, i franchi presero il controllo sia di Arsuf che di Cesarea. Nel 1102, i genovesi contribuirono alla caduta di Tortosa, e due anni dopo parteciparono alla presa di Giblet e, soprattutto, di Acri. Tripoli si arrese solo nel 1109 ed ai genovesi fu concesso un terzo della città. I veneziani ritornarono per prender parte alla conquista di Sidone e Tiro. Ovunque nascevano insediamenti italiani.
Tali stanziamenti rimasero poco più che piccole enclavi nei regni crociati, avamposti commerciali con pochi alloggi, uffici e magazzini. Tutto ciò aveva però una grande importanza, era lo spazio funzionale necessario a marinai e capitani di mare, mercanti e agenti, nelle loro brevi permanenze. Le loro famiglie rimanevano in Italia e solo gradualmente iniziarono a trasferirsi, accompagnando i familiari in stanziamenti più duraturi, come nel caso della famiglia Embriachi di Genova. Così, nel XIII secolo c’erano italiani residenti in Terra Santa di terza o quarta generazione, per lo più legati alle loro città d’origine sino al punto da riprodurre in Oriente lo scontro tra imperatore e comuni che infiammò l’Italia: i veneziani e i genovesi si opposero a Federico II e ai pisani che lo sostenevano.
L’ascesa di Venezia e la conquista di Bisanzio nel 1204 consegnarono alla Repubblica di San Marco il dominio sull’Epiro, Durazzo, Arta, Corfù, Zante, l’Etolia, l’Acarnania, il Peloponneso, le isole dell’arcipelago poste ad occidente di Nasso, Andro, Negroponte, Creta, Adrianopoli, Gallipoli, Rodosto e poi Caifa, Sidone, Tiro… I veneziani ebbero inoltre il possesso di tre ottavi della capitale. Tuttavia caduto l’Impero Latino, si fecero più agguerriti i genovesi. Nel 1262 ebbero da Michele Paleologo, col trattato di Ninfeo, l’esenzione da ogni dazio doganale, Smirne, fondaci ad Anea e Cassandra, consoli a Chio, Lesbo, Creta e Negroponte, e nei fatti il monopolio marittimo del Mar Nero. Li danneggiò l’espulsione del 1264, ma già tre anni dopo erano nuovamente a Costantinopoli, padroni del sobborgo di Galata, che trasformarono in una grande città genovese, cinta di mura, torri e fossi. Nel 1347 Galata aveva superato per ricchezza il commercio di Costantinopoli e ciò creò un lungo conflitto con gli imperatori che esplose in una vera e propria guerra al termine della quale Giovanni il Cantacuzeno riconobbe ulteriori diritti a Genova. Venezia seppe conservare la maggior parte delle sue conquiste, anzi le estese. Tuttavia il problema era ora rappresentato dai turchi e quando Tessalonica fu tolta al commercio italiano, ciò fu chiaro a tutti. La conquista ottomana di Costantinopoli portò al crollo di Galata. L’ultima colonia genovese, Chio, cadde nel 1566, nel 1571 fu la veneziana Cipro a finire sotto il controllo turco.
Autore articolo e foto: Angelo D’Ambra
Bibliografia: M. Baber, The Crusader States