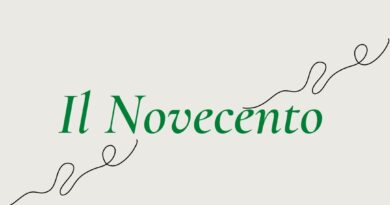Le province pontificie durante il papato avignonese
Dopo Clemente V si ebbero ben altri sei pontefici che risiederono ad Avignone e furono: Giovanni XXII, Benedetto XII, Clemente VI, Innocenzo VI, Urbano V e Gregorio XI, l’ultimo papa avignonese che rientrò a Roma nel 1377.
Durante questo arco temporale le province pontificie da quattro divennero cinque, così divise: Patrimonio di San Pietro, Campagna e Marittima, Ducato di Spoleto, Marca Anconitana e Provincia Romandiolae (ossia la Romagna).
Nel periodo avignonese l’amministrazione dei territori papali in Italia fu gestita dai legati pontifici, con l’obiettivo di mettere ordine sul suolo italico. Uno dei legati più noti fu Bertrand de Deux, vescovo di Embrun, che nel 1335 venne inviato, da papa Benedetto XII, come vicario generale e riformatore nei territori papali in Italia. Emanò le costituzioni per le 5 province pontificie concedendo privilegi e libertà ai comuni ma limitando la loro capacità d’azione in altri ambiti, cercando così di combattere la corruzione dilagante. Cosa erano le costituzioni provinciali? Erano atti parlamentari in quanto approvate dai parlamenti, il loro iter prevedeva tre fasi:
- L’editio ossia la presentazione di una proposta da parte del rettore;
- Recepetio, l’accettazione esplicita da parte del parlamento;
- Promulgatio, in sostanza la pubblicazione delle costituzioni.
Completate le tre fasi il rettore faceva inserire le costituzioni nel Liber Constitutionum Curiae Generalis e poi all’interno degli statuti comunali. Esaminato l’iter legislativo che portava alla pubblicazione di una costituzione, vogliamo portare all’attenzione una figura particolare ossia il più famoso dei legati pontifici, il cardinale Egidio di Albornoz, nominato, con la bolla di Innocenzo VI del 30 giugno 1353, vicario generale con il compito di riformare e conservare la pace nello stato della Chiesa. Aveva la facoltà di amministrare la giustizia d’appello, nominare o revocare funzionari, confermare o far decadere i privilegi dei signori feudali, confermare o abrogare gli statuti cittadini. I mezzi con cui poteva far tutto ciò erano due in sostanza: quello militare e quello giudiziario.
L’attività militare dell’Albornoz fu molto prolifica, diede vita a molte rocche fortificate, ne costruì e ne restaurò moltissime, si pensi alla Rocca di Orvieto che oggi porta il suo nome. Tra il 1356 e il 1357 egli impose la supremazia papale nel Patrimonio, nel Ducato e nella Marca, ottenne la sottomissione dei Polenta di Ravenna, conquistò Faenza togliendola ai Manfredi, conquistò Cesena e di li a poco Bertinoro. Infine conquistò Forlì, nel 1359, appena tornato da Avignone.
Meritevoli di attenzione sono le Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae o meglio conosciute come costituzioni egidiane (così chiamate per via del suo creatore) emanate da Albornoz, furono approvate dal Parlamento di Fano nel 1357 e pubblicate nello stesso anno. Per gran parte le anzidette costituzioni, divise in sei libri, furono la codificazione in una raccolta unitaria di quanto stabilito dai precedenti legati e rettori; la loro importanza deriva dal fatto che rimarranno in vigore, seppur con molti cambiamenti, fino al 1816.
L’Albornoz non fu soltanto un pregevole stratega militare ma anche un fine giurista e un diplomatico. L’istituzione più caratteristica della politica del cardinale fu il vicariato apostolico, in base al quale un signore o un comune otteneva il riconoscimento delle sue prerogative giuridiche e amministrative per un certo numero di anni dando in cambio una somma di denaro, il cd. census. In altri casi venne sostituita la signoria laica “ribelle” con una ecclesiastica del papa o dello stesso Albornoz, che governavano per mezzo di propri vicari. In quest’ultimo caso i vicari altro non erano che semplici “funzionari pontifici”, ben diversi dai vicari apostolici sopra citati. Secondo lo storico del diritto italiano Paolo Colliva (Il cardinale Albornoz. Lo Stato della Chiesa. Le Constitutiones Aegidianae, 1353-1357), il cardinale venne molto spesso a patto con i signori più che combatterli.
Per concludere questo articolo sul periodo avignonese e l’amministrazione delle province pontificie, bisogna segnalare che papa Urbano V tentò un ritorno a Roma tra il 1367 e il 1370 ma il rientro definitivo del papato nella città eterna si deve a Gregorio XI nel 1377; un anno dopo, nel 1378, il pontefice morì dando così l’avvio allo Scisma d’Occidente o Grande Scisma.
Autore articolo: Davide Alessandra
Davide Alessandra, laureando in giurisprudenza e studente di archivistica, paleografia e diplomatica presso la scuola dell’Archivio di Stato di Palermo.