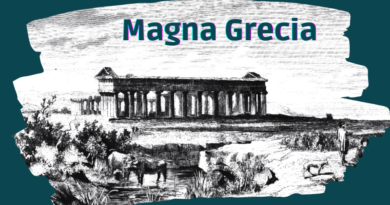Lamennais e l’Italia
Critico della Restaurazione, il Lamennais divenne poi il più grande liberale cattolico della sua generazione e influenzò notevolmente anche il dibattito in Italia.
Ancora nel Settecento si constatava una completa compenetrazione tra Stato e Chiesa nei paesi cattolici. Lo Stato era cattolico e considerava come sua prerogativa la difesa della concezione cattolica della vita, la Chiesa ricambiava riconoscendo al potere regio una origine divina della sovranità. Questa compenetrazione coinvolgeva la sfera politica e quella sociale. Vescovi e prelati ricoprivano spesso cariche politiche e diplomatiche, oltretutto il clero e gli ordini religioni dividevano con la nobiltà il possesso della maggior parte delle terre ed aveva in mano una serie di importanti funzioni pubbliche, dall’insegnamento all’assistenza. Tutto ciò trovava le sue radici nel Medioevo e nella sua struttura feudale e per questo la lotta dell’emergente borghesia contro le isituzioni feudali fu necessariamente anche una lotta contro la Chiesa. Questo si poteva leggere nella Riforma protestante che staccò alla Chiesa di Roma l’Europa settentrionale e parte di quella centrale e, nel corso del Settecento, si manifestò nella politica regalistica promossa dagli illuministri, tesa a stabilire o rafforzare la dipendenza dell’episcopato e del clero dall’autorità del re. In realtà già negli ultimi secoli del Medioevo le monarchie avevano cominciato a rompere l’universalismo papale, adesso però si puntava a limitare i privilegi del clero, a sottrargli parte delle funzioni pubbliche e degli introiti. Questa lotta politica finì con l’avere forti ripercussioni anche all’interno dello stesso cattolicesimo. Ciò vale soprattutto per la soppressione della Compagnia di Gesù, decisa da papa Clemente XIV nel 1773.
Durante tutto il secolo si sparsero gruppi di ecclesiastici aperti alle nuove idee illuministiche e miranti ad una riforma del cattolicesimo, come quello dei giansenisti. Anche questo gruppo rappresentò per molti aspetti un’espressione religiosa delle nuove esigenze sociali e politiche che accompagnavano l’ascesa della borghesia. Il punto culminante di questa lotta fu la Rivoluzione francese che dette i natali ad uno stato completamente laico e fondato sul principio della sovranità popolare. Allora, spaventata, l’aristocrazia, che era stata la classe più miscredente e libertina, divenne reazionaria ed i re, terrorizzati dalla ghigliottina, frenarono le politiche regalistiche. Un nugulo di libelli reazionari si diffuse in tutta Europa soppiantando in numero quelli del deismo razionalistico, del materialismo, dei giansenisti… Le Considerations sur la France di Joseph de Maiestre rappresentano certamente la più alte manifestazioni della letteratura controrivoluzionaria e cattolica.
Il Maistre, nato a Chambery nel 1753, fu per tutta la vita al servizio dei Savoia, prima come magistrato poi come diplomatico. Fu lui l’iniziatore del movimento cattolico in Piemonte. Con grande vigore polemico sostenne un’aspra critica dell’illuminismo e sfociando, nel Du Pape, in un rigido papalismo che anticipò d’un secolo il principio dell’infallibilità del pontefice. Intanto però in Francia emergeva anche un cattolicesimo liberale, animato da Madame de Stael e Benjamin Constant, che riuscì ad influire sensibilmente sulla politica della restaurata monarchia borbonica. Questa corrente iniziò a trovare il sostegno anche di quella parte della borghesia che, spaventata dal radicalismo egualitario dei giacobini, s’era allontanata dall’illuminismo e s’era riaccostata al cattolicesimo. La critica alla Restaurazione fu assunta in maniera radicale da Félicité de Lamennais con Essai sur l’indifference en matiere de religion, testo in cui questo abate bretone accusò i Borbone di essere venuti a patti con lo spirito rivoluzionario, firmando la Carta costituzionale, pur di riprendersi il trono.
In effetti i governi della Restaurazione, in tutta Europa, erano ben lontani dal soddisfare i reazionari più incalliti: le vecchie dinastie erano tornate ovunque, ma le istituzioni napoleoniche erano rimaste in piedi e la stessa Chiesa non era più legata allo stato come prima. Il Lombardo-Veneto conservò la legislazione regalistica degli Asburgo e in tutta Italia trionfava la politica dell’amalgama, non solo a Napoli con Luigi de’ Medici, anche in Toscana col Fossombroni e persino a Roma col cardinale Consalvi. Non esistette qui un movimento reazionario vivace come quello francese, ma solo uomini come il Principe di Canosa che, facendo proprio il pensiero di Lamennais, guidarono una violenta repressione poliziesca contro le sette liberali. A Modena, il Canosa fu seguito dall’abate Giuseppe Baraldi, a Torino dal marchese Cesare Taparelli d’Azeglio, il padre di Massimo. Il Lamennais li incontrò nel 1824. Fu ospite a Torino di Rodolfo de Maistre, figlio di Joseph, a Genova incontrò il Canosa, a Napoli incontrò il teatino siciliano Gioacchino Ventura, direttore del periodico controrivoluzionario l’Enciclopedia ecclesiastica. Di lì a poco però a costoro apparve chiaro i governi guardavano con diffidenza ai cattolici reazionari e che la Chiesa nel suo complesso non avrebbe mai fatto proprio le tesi del francese, tesi troppo estremiste che avrebbero spezzato l’alleanza tra il trono e l’altare. Se ne accorse lo stesso Lamennais che iniziò allora un’evoluzione verso il liberalismo.
Nel 1829 col libro Des progres de la Revolution et de la guerre contre l’Eglise, Lamennais iniziò a reclamare la libertà di istruzione, la separazione tra Chiesa e Stato, la libertà di coscienza, di stampa e di religione. Lamennais ora sosteneva che la restaurazione piena del cattolicesimo sarebbe avvenuta per mezzo della libertà, senza l’appoggio ed anzi contro il potere statale. Era un passo importante verso un programma cattolico-liberale che apparve effettivamente dopo la Rivoluzione di Luglio, sul giornale l’Avenir, da lui fondato col conte Charles de Montalembert ed il prete Henri-Dominique Lacordaire.
Il cattolicesimo liberale di Lamennais culminava nell’idea di ridurre lo Stato alle semplici funzioni amministrative, attribuendo alla Chiesa la direzione culturale della società. Osteggiato dai vescovi francesi perchè reazionario e guardato con timore da Roma perchè liberale, il Lamennais si vide condannare le sue tesi da papa Gregorio XVI con l’enciclica Mirari vos del 15 agosto del 1832. L’enciclica condannò il principio della separazione tra Chiesa e Stato, quello della libertà di coscienza, di opinione e di stampa. Lamennais però aveva seminato tanto e in Italia in molti erano pronti a seguirlo ancora.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: G. Candeloro, Il Movimento Cattolico in Italia