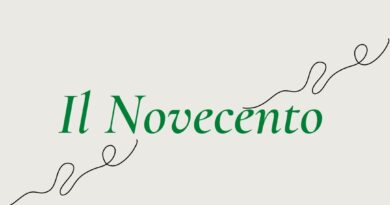La politica dell’amalgama
La seconda restaurazione borbonica impose una strada in apparenza semplice ma irta di ostacoli quella della politica dell’amalgama.
Luigi de’ Medici di Ottajano, Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno delle Due Sicilie, si fece portavoce di una via per evitare sia pericolose fughe in avanti verso sistemi costituzionali sia contro retrocessioni verso l’universo dei valori dell’ancien regime che avrebbe destabilizzato l’intero impianto burocratico ed amministrativo lasciato dai napoleonidi. La politica dell’amalgama garantiva il controllo delle opposte tendenze, la dissoluzione dei vecchi rancori, il consenso dei ceti medi e dei militari murattiani. Alla base di tutto ciò c’era la convinzione della irreversibilità delle trasformazioni introdotte dal Decennio francese.
La messa in pratica della politica dell’amalgama però non fu affatto esente da problematiche ampie. Le condizioni sociali e politiche del Paese erano tali che i sostenitori del progetto della monarchia amministrativa si trovarono contro sia i liberali che i reazionari, di fatti disegnando uno scenario di scontro a tre.
Il Medici riuscì da subito ad emarginare il Ministro degli Esteri, il Marchese del Circello, fautore di un ritorno completo all’ancien regime. Qualche ostacolo lo creò invece il massimo esponente del fronte reazionario, il Principe di Canosa. Questi dopo una prima fase piuttosto morbida, passò a serrate misure repressive contro massoni e carbonari, quando però giunse apertamente a sostenere la necessità di schierarsi con la setta reazionaria dei Calderari, si aprì lo scontro col Medici. In un incontro ministeriale i due per poco non vennero alle mani e, messo alle strette, il re Ferdinando accettò le dimissioni di Canosa nominando un nuovo direttore del Ministero di Polizia.
Dato che i più grandi cambiamenti del periodo francese interessarono l’ordinamento giuridico e l’amministrazione della giustizia, è qui che si concentrarono le principali attenzioni dei protagonisti della Restaurazione a Napoli. Le riforme del Decennio, influenzate dall’esperienza del 1789, tendevano ad una partecipazione effettiva dei cittadini alla vita dello Stato, seppur nell’accezione censitaria, e non cancellarle imponeva una strada assolutista ma comunque antibaronale, lontana dalle follie giacobine ma legata comunque al vecchio illuminismo napoletano. Il Ministro di Grazia e Giustizia, Donato Tommasi, Marchese di Casalicchio, si dedicò in modo particolare alla figura del Giudice di Pace confermando le attribuzioni napoleoniche ed ampliandole. Un riordino del personale portò all’allontanamento dei più rigidi murattiani e il cosiddetto amalgama si completò col reclutamento di giudici in grado di poter coniugare moralità e capacità tecniche tra emigrati, vecchi impiegati e perseguitati dal regime francese.
Si chiudeva così la riorganizzazione del personale all’insegna del tentativo di coniugare l’efficienza con la fedeltà alla dinastia.
Queste due importanti figure, il Medici ed il Tommasi, erano loro stesse le migliori rappresentanti dell’assolutismo illuminato. Entrambi amici di Gaetano Filangieri, Melchiorre Delfico e Mario Pagano, il Medici, in odore di giacobinismo, finì per due volte in galera, seguì Ferdinando in Sicilia ma nel 1811, dopo uno scontro coi baroni in parlamento, preferì l’esilio a Londra, il Tommasi fu liberale e massone eppure, fedele a Ferdinando I ne fu Ministro di Casa reale, azienda e commercio in Sicilia. Con loro, nei fatti, il Regno, ormai finito nell’orbita uastriaca, si scagliò contro i baroni riprendendo idealmente la politica di fine Settecento, ma fu la Sicilia a subire l’impatto più duro perdendo la Costituzione e subendo l’introduzione del sistema amministrativo di derivazione francese.
La complessità di tale politica creò numerosi problemi anzi, secondo Schipa, Carrascosa e Blanch, fu causa della rivoluzione del 1820 per l’incapacità di assorbire le spinte autonomistiche delle provincie e della Sicilia, maturate con l’esperienza francese. La politica dell’amalgama, tesa a creare equilibrio tra esponenti antimurattiani e murattiani con l’assorbimento delle istituzioni napoleoniche, fu sorda al malcontento di una intellettualità costituzionalista che continuava ad organizzarsi in società segrete. Il progetto ministeriale di portare a perfezione la monarchia amministrativa fallì quando, giunti gli austriaci a Napoli, il Canosa dettò una nuova riorganizzazione burocratica con la sostituzione del personale liberaleggiante con uno di orientamento controrivoluzionario. Sarà poi anche lui nuovamente allontanato.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: E. Gin, Sanfedisti, Carbonari, Magistrati del Re, Napoli 2003