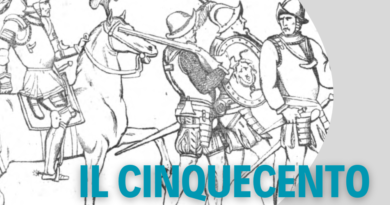La diffusione dei Baccanali ed Annia Paculla
Nell’antichità romana, i Baccanali ebbero enorme successo per gli smisurati quantitativi di vino cui era facile accedere ma soprattutto per i riti di tipo orgiastico che finirono con l’ababtere le regole morali della società.
Secondo quanto riportato da Tito Livio i culti bacchici si sarebbero diffusi a seguito di sostanziali riforme introdotte in ambienta campano su iniziativa della sacerdotessa Annia Paculla.
Livio descrive i Baccanali come riservati alle sole donne, un rituale sessuale diurno che si tiene esclusivamente per tre giorni dell’anno e che Paculla corruppe in forme lascive ed orgiastice. Forse il racconto liviano non va preso alla lettera, perchè i nuovi culti nuovi, soprattutto quelli segreti, erano spesso visti con ostilità dall’opinione pubblica, dunque la sua storia sarebeb carica di esagerazioni.
Ad ogni modo il culto si diffuse dalla Campania.
Intorno al 188 a.C., la sacerdotessa introdusse al culto anche gli uomini, a cominciare dai suoi figli Minius ed Herennius Cerrinius, e trasformò i riti di iniziazione da diurni in notturni aumentandone la frequenza a cinque giorni al mese. Li rese aperti a partecipanti di qualsiasi estrazione sociale senza più distinzioni di sorta e con queste modifiche ne garantì una enorme diffusione.
Il culto ebbe largo successo soprattutto perchè acquisi l’aspetto di una religiosità dei diseredati. Vi trovarono accoglienza, oltre alle donne, anche i giovani non ancora in età adulta e gli “uomini più simili alle donne”. A rivelare sconcertati particolari di queste orge furono un iniziato e la prostituta Hispala Faecenia. Grazie a loro partì l’indagine del Senato che portò alla soppressione del culto con una violenta repressione a seguito del decreto senatus consultum de Bacchanalibus nell’186 a.C..
In accordo alla testimonianza di Hispala, si scoprì che il culto non solo permetteva orge ma anche violenze d’ogni tipo. Processioni e danze di maschi vestiti da Satiri e femmine vestiti con Menadi, si trasformavano in orgie in cui i partecipanti ubriachi si abbandonavano anche a delitti .
Scrive Tito Livio riferendo della confessione di Hispala: “Gli uomini come impazziti vaneggiavano gesticolando da invasati con tutta la persona, le matrone in atteggiamento di baccanti, coi capelli sparsi, correvano giù fino al Tevere con torce accese e, dopo averle immerse nell’acqua, poiché queste contenevano zolfo vivo e calce, le estraevano con la fiamma intatta. Si dicevano rapite dagli dei persone che invece, legate a un ordigno, erano sottratte alla vista in spelonche nascoste; ed erano quelle che non avevano voluto congiurare né associarsi a misfatti o subire oltraggio. Erano una folla numerosa e ormai quasi un secondo popolo, e, fra questi, taluni cittadini e donne della nobiltà. Da due anni si era stabilito che nessuno fosse iniziato dopo i vent’anni di età; si cercava di attirare l’età più facile all’errore e più docile all’oltraggio. Giunta alla fine della sua denunzia e gettatasi di nuovo in ginocchio, ripeté le solite preghiere per essere confinata lontano. Il console chiede alla suocera di sgombrare una parte della casa, dove Hispala potesse trasferirsi. Le fu assegnata infatti una soffitta sopra il palazzo, chiudendo l’accesso alle scale che portavano sulla via e aprendo un passaggio verso l’interno. Vi furono trasportate subito tutte le cose di Fecennia e vi furono fatti venire i suoi servi; e Ebuzio fu trasferito presso un cliente del console. Mentre in tal modo tutti e due i delatori erano in mano sua, Postumio riferisce la cosa al senato facendo una ordinata esposizione di tutto, di ciò che prima gli era stato denunziato, e di ciò che in seguito aveva indagato direttamente. I senatori furono presi da un grande panico, sia per l’interesse pubblico, che quelle congiure e quelle conventicole notturne non avessero a portare occulti pregiudizi o pericoli, sia anche personalmente per i familiari di ognuno, che non ce ne fossero implicati in quella colpa. Il senato deliberò di ringraziare il console per aver condotto l’indagine con particolare oculatezza e evitando ogni disordine. Quindi si affida ai consoli la procedura straordinaria contro i Baccanali e i riti notturni in genere; si dispone di evitare che ai due delatori Ebuzio e Fecennia la cosa porti pregiudizio, e di attirare con premi altri delatori. Si fan ricercare non solo a Roma, ma per tutti i fori e i conciliaboli i sacerdoti di quei riti, uomini e donne che fossero, per darli in mano ai consoli; ancora si fa decretare nella città di Roma, e analoghi editti si mandano per tutta Italia, che chi fosse già iniziato ai Baccanali si astenga dal partecipare a riunioni a scopo cultuale e dal compiere atto alcuno di simili riti; soprattutto si proceda contro coloro che abbiano congiurato o si siano adunati per commettere stupro o altra infamia. Questo decise il senato. I consoli ordinarono agli edili curuli di ricercare tutti i sacerdoti di quel culto, e, trattenendoli in libera custodia, tenerli a loro disposizione per l’inchiesta; gli edili della plebe vigilassero che non fossero celebrati riti in luogo chiuso. Ai triumviri capitali fu dato incarico di dislocare qua e là per la città delle guardie e sorvegliare che non si tenessero adunanze notturne, e, per prevenire incendi, i quinqueviri costituiti al di qua e al di là del Tevere come ausiliari addetti ai triumviri, dovevano sovrintendere ciascuno agli edifici del proprio quartiere”.
“Nella notte che seguì al giorno nel quale la scoperta era stata resa di pubblica ragione dinanzi al popolo, – scrive ancora lo storico romano – quelli che tentavano di fuggire, con posti di blocco presso le porte furono fermati dai triumviri e ricondotti indietro; molti furono denunziati. Alcuni di essi, uomini e donne, si uccisero. Si diceva che i congiurati fra uomini e donne fossero oltre settemila. Si sapeva che a capo della congiura erano M. e C. Atinio della plebe romana e il falisco L. Opicernio,e Minio Cerrinio della Campania:da questi erano partite tutte le iniziative vergognose; erano essi precisamente i sacerdoti e gli organizzatori di quei riti. Si dettero disposizioni per arrestarli al più presto. Condotti davanti ai consoli, confessarono per la parte loro e non tardarono a passare alle denunce.Pure, era diventato così generale l’esodo da Roma che molti lasciavan perdere le cause civili e i relativi diritti; sicché i pretori T. Menio e M. Licinio furono costretti, con l’intervento del senato, a differire gli affari civili fino a trenta giorni, finché i consoli non avessero esaurito i loro processi. Le assenze costrinsero ancora i consoli, poiché a Roma non comparivano e non si trovavano quelli che erano denunziati, a andare in giro per i fori e istruirvi processi e esercitare la loro giurisdizione. Se uno era stato soltanto iniziato e aveva pronunciato, secondo la formula sacramentale suggerita dal sacerdote, i voti che legavano l’infame setta a delitti e arbitrii di ogni sorta, ma non aveva macchiato né sé né altri di nessuna di quelle onte a cui era obbligato dal giuramento, allora lo lasciavano in catene; quelli che si erano disonorati con stupri o uccisioni, o che si erano macchiati di false testimonianze, di alterazione di suggelli, di supposizione di testamenti o di altre frodi, li condannavano a morte. Furono più gli uccisi che quelli imprigionati: ma tanto nell’uno che nell’altro caso grande fu il numero, sia di uomini che di donne. Le donne condannate le consegnavano ai parenti o a chi esercitava su di loro la tutela, perché direttamente provvedessero contro di loro in privato; se non c’era nessuno che avesse i requisiti di giustiziere si provvedeva in sede pubblica. Fu dato quindi incarico ai consoli di abbatter gli oggetti del culto bacchico prima a Roma, poi in tutta Italia, tranne il caso che vi fosse qualche antica ara o qualche statua consacrata. Per l’avvenire quindi si provvide per senatoconsulto che non si tenessero Baccanali né a Roma né in Italia; se uno riteneva un tale culto consacrato dall’uso e obbligatorio, e dichiarava dinanzi al pretore urbano di non potersene astenere senza uno scrupolo religioso e senza una espiazione, il pretore consultasse il senato; se, presenti in senato non meno di cento membri, si concedeva l’esenzione, celebrasse il rito, a condizione che non assistessero al sacrificio più di cinque persone e non vi fosse una cassa comune né un presidente di collegio o un sacerdote”.
Livio afferma che in settemila, tra uomini e donne, furono condannati e che gli arresti includevano il figlio di Paculla, Minius Cerrineus, mentre la fine della sacerdotessa ci è sconosciuta. Coloro che furono riconosciuti soltanto iniziati ai misteri, ma innocenti di qualunque altra turpitudine o delitto, furono lasciati in prigione, quelli invece che si erano macchiati di stupri o di omicidi, furono puniti di pena capitale.
Tuttavia baccanali illeciti continuarono a lungo ad essere celebrati, in particolare nell’Italia meridionale.
Autore articolo: Angelo D’Ambra