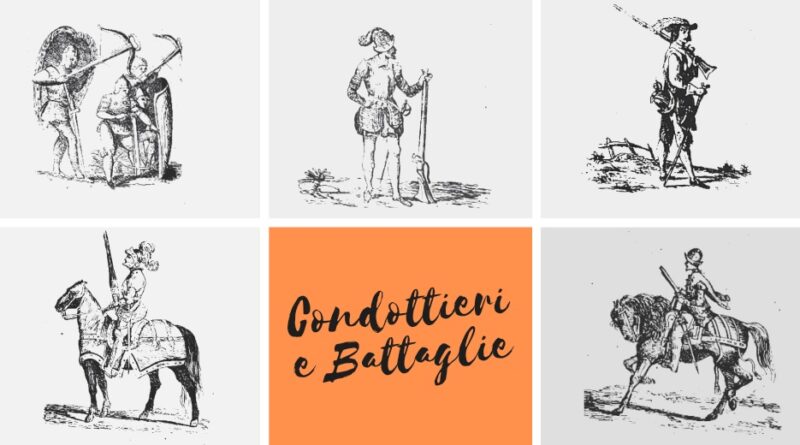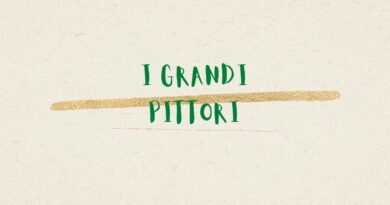La Battaglia di Civitate
Poche battaglie nella storia d’Italia sono gravide di significato come Civitate, questo scontro feroce sulle rive del Fortore tra un composito esercito raccolto da un papa tedesco e una moltitudine di avventurieri normanni venuti nella parte meridionale dello stivale a cercare ricchezze e fortuna. Di fatto a Civitate, e più formalmente con il successivo Trattato di Melfi, nacque l’Italia meridionale come entità politica unitaria a se stante, legata a Santa Romana Chiesa da un rapporto particolarissimo che si sarebbe protratto, in un’infinita serie di alti e di bassi, sino all’età contemporanea e alla caduta del Regno delle Due Sicilie.
All’inizio del secondo millennio dell’era cristiana l’Italia meridionale era suddivisa sostanzialmente in due parti: un largo territorio dipendente dall’Impero Bizantino, comprendente Puglia, parte della Basilicata e Calabria, con capitale a Bari, e una serie di staterelli prevalentemente di origine longobarda che occupavano la Campania, l’Abruzzo e il Molise: i principati di Capua, Salerno e Benevento e i ducati di Amalfi e di Napoli (Napoli era in realtà bizantina in carattere, e si considerava vassalla di Costantinopoli). Tali stati riconoscevano in generale l’autorità del Sacro Romano Impero ma erano di fatto indipendenti.
Lo Stato della Chiesa, immediato vicino settentrionale dei principati longobardi e non ancora in conflitto con il Sacro Romano Impero, esercitava una notevole influenza politica su di essi e il Papa funzionava un po’ come da rappresentante imperiale nei territori. I principati longobardi e i territori bizantini erano in preda ad una conflittualità endemica, i principati tra loro, i principati contro i bizantini, i sudditi italici e longobardi dei bizantini contro gli amministratori greci.
Piccoli gruppi di avventurieri normanni, originari del Ducato di Normandia, vennero nel paese nei primissimi anni del secolo e si impiegarono come mercenari al servizio ora dei principi longobardi, ora del catapano bizantino, ora dei nobili longobardi ribelli all’autorità bizantina in Puglia. Ebbero estremo successo e tale successo venne ricompensato con concessione di terre: è del 1030 la concessione al normanno Ranulfo Drengot della contea di Aversa da parte del duca Sergio IV di Napoli, costituendosi così il primo stato normanno. Nel 1035 arrivarono nel sud tre fratelli normanni, Guglielmo, Drogo e Umfredo, appartenenti alla famiglia Hauteville, italianizzato in Altavilla e diedero immediatamente ulteriore impulso alla conquista. Altri due fratelli Altavilla sarebbero seguiti con grandi glorie, Roberto “il Guiscardo” e Ruggero, il conquistatore della Sicilia.
Negli anni tra il 1040 e il 1050 l’attività normanna si intensificò e crebbero le loro conquiste, anche a spese dei Bizantini: l’imperatore Enrico III nel 1046 conferì a Drogo d’Altavilla il titolo di Duca di Puglia. Ma a questo punto il gioco era più che mai scoperto e tanto longobardi quanto bizantini divennero in breve largamente ostili ai nuovi venuti, i quali ricambiarono l’ostilità con l’oppressione.
Nel 1051 il duca Drogo fu assassinato da locali, sobillati dai Bizantini. Il papa, più del lontano imperatore tedesco, divenne in breve il campione di tale opposizione indigena ai nuovi venuti. Sedeva dal 1049 sul trono di Pietro un nobile tedesco, Bruno di Egisheim-Dagsburg, con il nome di Leone IX. Fedele all’imperatore Enrico III si fece in breve interprete di una vocale politica volta a espellere i Normanni dall’Italia meridionale. Coinvolse nella sua coalizione pure i Bizantini e iniziò a raccogliere truppe, soprattutto nella Germania meridionale.
L’esercito pontificio che nella primavera del 1053 mosse verso le Puglie comprendeva cavalieri e fanteria tedesche, soprattutto dalla Svevia, e contingenti da praticamente tutti i potentati e le signorie longobarde dell’Italia meridionale, con la notabile eccezione di Salerno. Un esercito bizantino, guidato dal catapano Argiro, mosse da Bari verso nord per prendere i Normanni, il cui centro principale era allora Melfi, in una tenaglia. Umfredo d’Altavilla, fratello e successore di Drogo, mosse in fretta per evitare il congiungimento dei due nemici; tutte le forze normanne si concentrarono presso Melfi, anche i Drengot da Aversa, poiché era chiaro a tutti che la battaglia sarebbe stata decisiva.
L’esercito pontificio raggiunse Civitate (l’odierna San Paolo di Civitate, cittadina a nord-ovest di Foggia) sul fiume Fortore ove si trovò a fronteggiare i Normanni prima che i Bizantini fossero arrivati. Il pontefice rimase in Civitate, e l’esercito fu comandato sul campo da Gerardo, Duca di Lorena (capostipite fra l’altro dell’odierna Casa d’Asburgo-Lorena), parente di Leone IX. Le truppe longobarde erano capitanate dal principe Rodolfo di Benevento. I collegati avevano pare una larga superiorità numerica. Sul campo tuttavia i Normanni ebbero presto ragione delle schiere longobarde, che presero la fuga, e soli rimasero i tedeschi, che si batterono sino alla fine, avendo tuttavia la peggio. La sconfitta pontificia fu totale.
I Normanni presero prigioniero il papa, forse consegnato loro dai cittadini di Civitate, mentre il catapano Argiro si ritirò, non sentendosela di affrontare i Normanni da solo.
Con papa Leone i Normanni entrarono in trattativa rilasciandolo dopo dieci mesi senza nulla aver ottenuto. Tuttavia Civitate aveva cambiato la situazione per sempre.
Leone IX morì l’anno dopo, nel 1054 lo Scisma d’Oriente seppellì per sempre ogni possibilità d’alleanza con Bisanzio e nel 1056 morì pure il forte imperatore Enrico III, lasciando l’impero ad un bambino che poi sarebbe diventato famoso come il più ostinato avversario dei papi. I principi longobardi furono tagliati fuori da ogni decisione, ormai troppo indeboliti. Nel 1059 si arrivò infine al Trattato di Melfi, con cui papa Niccolò II riconobbe Roberto “il Guiscardo” come Duca di Puglia e Riccardo Drengot come Conte di Aversa e Principe di Capua. L’inimicizia tra la Santa Sede e i Normanni finì lì e negli anni successivi Roberto “il Guiscardo” avrebbe salvato papa Gregorio VII dalla furia di quel bambino diventato l’imperatore Enrico IV, trasformandosi una sorta di protettore del papato.
Nei settant’anni successivi i principi della Casa d’Altavilla avrebbero conquistato tutti i residui territori longobardi e bizantini, strappato agli Arabi la Sicilia e riunito tutti i territori normanni con il beneplacito papale nel Regno di Sicilia, riconoscendosi vassalli del Pontefice e impegnandosi al versamento di un simbolico tributo annuale. Pur venendo in seguito il vassallaggio svuotato del suo significato tale situazione, attraverso cambiamenti dinastici, guerre e dominazioni straniere, sarebbe rimasta nella sua sostanza sino all’unità d’Italia.
Autore articolo: Valerio Lucchinetti
Bibliografia: AA.VV., The Cambridge Medieval History, Vol.III, Germany and the Western Empire, Cambridge, 1922; F, Chalandon, Histoire de la domination normanne en Italie et en Sicile, Parigi, 1907; F. Gregorovius, Storia della città di Roma nel Medioevo (trad.ital.), Roma, 1972; J. Norwich, I Normanni nel Sud (1016-1130) (trad.ital.), Milano, 1971
Valerio Lucchinetti, laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano con tesi di storia economica sui mercati granari in Lombardia nel XVIII secolo. Attivo professionalmente nel settore della gestione di portafogli azionari è appassionato di storia, con preferenza per il Medio Evo e l’età moderna sino alla Rivoluzione Francese.