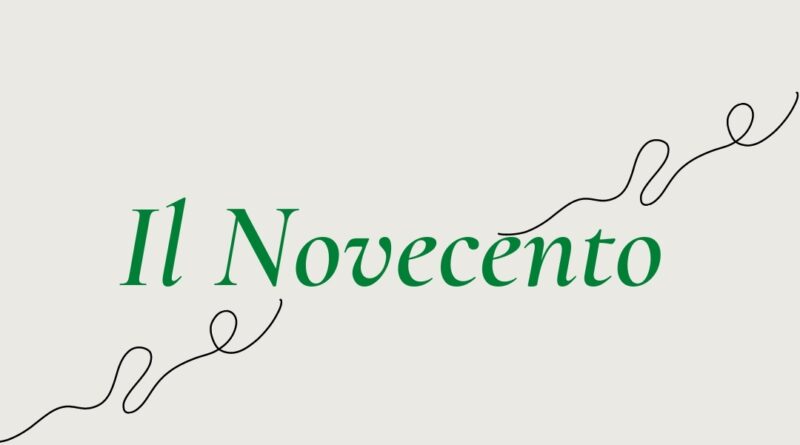Il corpo elettorale in Italia
Il corpo elettorale ha avuto in Italia diverse e lente trasformazioni. La storia della democrazia nel nostro paese ha una data di nascita precisa, il 4 marzo del 1848, giorno in cui Carlo Alberto di Savoia approvò lo statuto che da lui prende il nome. L’esordio della democrazia si ebbe dunque nell’anno rivoluzionario del 1848 e lo Statuto albertino pose le basi per un lungo cammino di partecipazione popolare alla vita politica nazionale.
La prima legge elettorale piemontese risale al 17 marzo di quell’anno. Le elezioni si tennero il 27 aprile e diedero al Regno di Sardegna, allora comprendente Piemonte, Sardegna, Savoia, Liguria e Nizza, il primo parlamento della sua storia. Gli elettori furono i cittadini di sesso maschile che avevano compiuto almeno venticinque anni, che sapevano leggere e scrivere e che pagavano un censo annuo di imposte pari almeno a 40 lire (ridotte della metà per Liguria, Savoia e Nizza). L’insieme di queste quattro limitazioni diede il diritto al voto all’1,7% dell’intera popolazione e di esso non esercitò il diritto che lo 0,7%. Buona parte del corpo elettorale, infatti, riteneva il voto una sorta di irriverenza per l’amato sovrano. Si aggiunga che più del 30% delle poche schede andò invalidato. Il cammino democratico del Paese era evidentemente tutto in salita.
Il primo parlamento piemontese fu composto da 222 deputati (e tra essi Garibaldi e Cavour, eletti rispettivamente con 63 e 165 voti). Il Senato, invece, era costituito da elementi di nomina regia. Ne derivò un governo che vide Cesare Balbo presidente, Vincenzo Gioberti ministro senza portafoglio, Vincenzo Ricci agli esteri, Luigi Des Ambrois De Nevache ai lavori pubblici, Lorenzo Pareto agli interni, Carlo Bon Compagni di Mombello all’istruzione, Antonio Franzini alla guerra, Ottavio Thaon di Revel alle finanze, Federico Paolo Sclopis di Salerano agli affari ecclesiastici.
Ad unità avvenuta, questa stessa legge elettorale fu estesa a tutta l’Italia, escluso il Veneto ancora sotto gli austriaci. L’ottava legislatura, si continuò infatti nella numerazione del parlamento sabaudo, vide votare l’1,9% della popolazione. Gli eletti salirono a 443 (508 dopo il plebiscito veneto). I deputati furono eletti con una media di 316 voti. La situazione restò invariata per ancora un ventennio. Nelle elezioni del 1880 i votanti salirono al 2,2% e solo due anni dopo si assistette ad un allargamento del suffraggio. L’età per votare fu abbassata a 21 anni, il censo scese da 40 a 19,80 lire di tributi annui. Quanto all’istruzione, fu sufficiente aver superato l’esame delle elementari, caso in cui non era richiesta la qualifica di contribuente. Fu cos che gli elettori divennero il 7% della popolazione.
Il suffraggio allargato del 1912 innalzò l’elettorato attivo a tutti i cittadini di età superiore ai 30 anni, ferme restando per quelli fra i 20 e i 30 le limitazioni di censo. Gli elettori divennero il 23%. Le donne continuavano a restare escluse e così sino allalegge del 2 febbraio 1945. Nel frattempo tante cose erano mutate. Erano comparsi i partiti. Nel 1895 s’erano presentati alle elezioni quello socialista e quello radicale, nel 1900 apparve quello repubblicano, nel 1913 quello liberale e, nel 1921, in seguito a una scissione coi socialisti a Livorno, sorse quello comunista. Era pure stata superata l’intransigenza dei cattolici che, in solidarietà al Papa spodestato da Roma si erano astenuti dal voto. Era poi stata superata la parentesi fascista che aveva portato, nel 1928, a votare un unica lista nazionale e, nel 1939, alla Camera dei fasci e delle corporazioni di cui andavano a far parte d’ufficio tutti coloro cherivestivano determinate cariche politico-amministrative.
Dai primi passi del 1848 al suffraggio universale, la democrazia era cambiata totalmente e con la svolta repubblicana mutò ancora: i candidati alle Camere, che per la Costitutente del 1946 erano stati 4764 per 556 seggi, salirono nelle elezioni del 1968 a 5843 per 630 seggi alla Camera e a 1523 per 315 al Senato.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: G. Licata, Il cammino della democrazia in Italia, Corriere della Sera, 7 maggio 1972