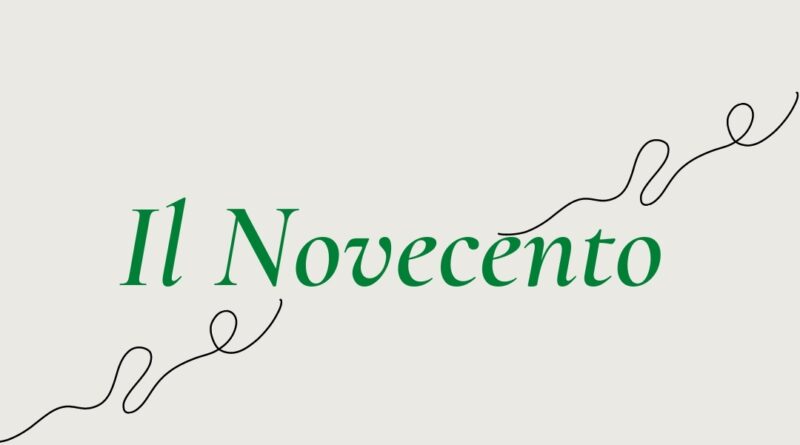Giovanni Palatucci, il questore di Fiume che aiutò gli ebrei
Giovanni Palatucci, nativo di Montella, in Irpinia, morì in un campo di concentramento nazista, quello di Dachau, per avere, in qualità di questore di Fiume, salvato oltre cinquemila ebrei.
Dopo la maturità conseguita a Salerno nel 1928, svolse nel 1930 il servizio militare a Moncalieri come allievo ufficiale di complemento. Iscritto al Partito Nazionale Fascista, nel 1932 conseguì la laurea in legge a Torino. Nel 1936 giurò come volontario vice commissario di pubblica sicurezza. Nel 1937 venne trasferito alla questura di Fiume come responsabile dell’ufficio stranieri e, negli anni successivi, fu commissario e questore reggente.
A Fiume visse in Via Pomero 29, presso la famiglia Malner, vicino ad una delle due sinagoghe cittadine. Di lì a poco le leggi razziali e poi lo scoppio della guerra col rafforzamento dell’asse fra Italia e Germania nazista, apriranno un periodo difficile e buio per Palatucci. La comunità ebraica locale – circa 1635 persone – usciva da un clima di piena integrazione e serenità. Un accavallarsi di norme e interpretazioni portano a censire tutti gli ebrei della provincia e a molti di essi è revocata la cittadinanza ed intimato d’abbandonare Fiume. In quel contesto, Palatucci cercò di fare quello che la sua posizione gli permetteva, creando, attraverso una rete di amici, una strada per salvare tanti ebrei dai campi di sterminio, proteggendo i loro viaggi verso Israele e evitando le deportazioni. In una lettera ai genitori scrisse: “Ho la possibilità di fare un po’ di bene, e i beneficiati da me sono assai riconoscenti. Nel complesso riscontro molte simpatie. Di me non ho altro di speciale da comunicare”. E fu così.
Rodolfo Grani, ebreo fiumano che conobbe personalmente Palatucci, lo ricordò come “nobilissimo giovane cattolico” e riferì di un suo primo grande intervento di salvataggio del marzo 1939. Palatucci mise in salvo alcuni profughi tedeschi che dovevano essere consegnati alla Gestapo. Erano circa ottocento ebrei, ex emigrati del vapore greco Aghia Zoni, partito da Fiume il 16 marzo 1939 per raggiungere Israele. In quella circostanza avvisò tempestivamente Grani, il quale ottenne l’intervento del vescovo Isidoro Sain che, a sua volta, nascose i profughi nella vicina località di Abbazia sotto la sua protezione.
In quell’anno riuscì anche ad ottenere la revoca di un provvedimento che lo spostava a Caserta per continuare ad aiutare i perseguitati in quel momento che diveniva sempre più cupo.
Si servì anche dei suoi contatti familiari. Infatti… Con l’entrata in guerra, l’internamento degli ebrei stranieri, prima solo minacciato, divenne operativo. Il 16 maggio 1940 venne stabilito che gli ebrei apolidi fossero trasferiti in campo di internamento. Fu così che nacque il campo di Campagna, in provincia di Salerno, località dove uno zio di Giovanni era vescovo: Giuseppe Maria Palatucci. Per circa tre anni i due riuscirono a salvare numerosi ebrei inviandoli da Fiume a Campagna. Quì il prefetto Bianchi aveva individuato un luogo giusto per l’istituzione di un campo sfruttando le caserme dell’Immacolata Concezione e l’ex convento di San Bartolomeo. Nel giugno del 1940 il campo era pronto. Novecento erano i posti a disposizione, la vigilanza era affidata ad un distaccamento di pubblica sicurezza costituito da dodici agenti e da un nucleo di carabinieri, la direzione era collocata poco lontano, in Via Giulio Cesare Capaccio. Grazie all’intervento diretto del vescovo, gli internati godettero di una libera uscita dalle ore 13 alle 20 d’ogni giorno, potevano consumare altresì i loro pasti fuori dal campo. Non c’erano recinzioni intorno al sito e gli internati solidarizzarono con la popolazione locale e gli stessi addetti di vigilanza. La collaborazione tra popolazione, internati e forze dell’ordine creò, in silenzio, un luogo accogliente con attività culturali, sportive e ricreative. Giovanni aveva il compito di ostacolare il movimento clandestino di emigrazione ed espellere i turisti illegali da Fiume, ma sabotò certe disposizioni affidando gli ebrei alla protezione di suo zio vescovo, almeno fino al settembre del 1943, quando il campo di Campagna fu chiuso a causa delle numerose incursioni aeree.
La notte fra il 18 ed il 19 giugno 1940, tutti gli ebrei maschi di Fiume fra i diciotto ed i sessant’anni furono arrestati e rinchiusi nella scuola di Torretta. Giovanni Friedman, professionista molto stimato in città, si tolse la vita gettandosi dal quarto piano. In tanti già temevano una orribile fine. Alcuni furono rilasciati dopo due settimane di detenzione proprio per l’intervento di Palatucci che ottenne che gli arrestati fossero instradati a Campagna. Non poté salvare tutti, ma ci provò. E’ impossibile individuare un numero preciso di ebrei che trovarono protezione in provincia di Salerno, probabilmente non furono meno di quattrocento.
In base alle ricostruzioni ed alle testimonianze, sappiamo che Palatucci salvò in totale circa cinquemila ebrei, aiuto molti di essi, provenienti soprattutto da Zagabria, a sfuggire a nazisti e ustascia croati, entrando in Italia con documenti falsi. “Era un santo, non aveva paura, aiutava tutti ed era molto ben voluto”, ricordò l’ebrea Elsa Herskovits Blasich. “Ho conosciuto il dottor Giovanni Palatucci in casa dei miei genitori a Giume nel 1938; era buon amico di mia sorella Anna. La disponibilità del commissario Palatucci era nota, ha dato tutto il possibile aiuto agli ebrei fiumani e in seguito anche a quelli jugoslavi riusciti a riparare in Italia, sfuggendo alla morte. Mia sorella Anna ha potuto emigrare nel 1942 solo perchè aiutata dal dottor Palatucci a ottenere il passaporto rosso riservato agli apolidi”.
Sono molte le testimonianze che parlano dei suoi interventi, del suo coraggio, della sua incrollabile fede cattolica. Ricordò un suo collaboratore, Americo Cucciniello, che si esponeva in prima persona parlando col prefetto “quando si trattava di risolvere problemi di famiglie ebree che provenivano dai territori occupati dai tedeschi, alcune delle quali chiedevano personalmente a lui di interessarsi per favorire il transito attraverso l’Italia e la Spagna per raggiungere l’America del Sud”.
Nel novembre 1943 Fiume, pur facente parte della Repubblica Sociale Italiana, di fatto entrò a far parte della cosiddetta Zona d’operazioni del Litorale adriatico, controllata direttamente dalle truppe tedesche per ragioni d’importanza strategica e il comando militare della città passò al capitano delle SS Hoepener. Pur avvisato del pericolo che correva col continuare a difendere e nascondere ebrei, Palatucci decise di rimanere al suo posto. Addirittura quando il console svizzero di Trieste, un suo caro amico, gli offrì un passaggio sicuro verso la Svizzera, egli accettò ma gli inviò al suo posto una giovane ebrea, originaria di Karlovać, Mika Eisler, probabilmente la sua fidanzata. Il questore Palatucci osò pure vietare il rilascio di certificati alle autorità naziste se non su esplicita autorizzazione, così da poter aver notizia anticipata dei rastrellamenti e poterne dar avviso. Inoltre inviava relazioni ufficiali al governo della Repubblica Sociale Italiana per segnalare continue vessazioni, limitazioni nello svolgere le proprie attività e il disarmo dei poliziotti italiani da parte dei tedeschi. La sua opera di aiuto proseguì anche sotto l’asfissiante presenza tedesca. Faceva scappare gli ebrei prima che loro facessero irruzione nelle loro abitazioni, nascondeva quelli arrivati da fuori e ne favoriva l’imbarco prima che fossero identificati all’anagrafe, poi tra i nazisti sorsero sospetti su di lui.
Il 26 febbraio 1944 ci fu una prima irruzione delle SS nella casa di Palatucci. Inziarono a girare voci, delazioni, diffidenze. Il cerchio si strinse attorno a lui, fu controllato e spiato. Furono rinvenute delle missive tra lui e i gruppi autonomisti fiumani. Fiume era sempre stata una città confluenza di diverse etnie, non poteva restare inghiottita dal nazismo. Fu proprio con l’accusa formale di cospirazione e intelligenza con il nemico in seguito al “rinvenimento di un piano relativo alla sistemazione di Fiume come città indipendente, tradotto in lingua inglese” che lo fermarono. Reo d’aver “mantenuto contatti con il servizio informativo nemico”, il 13 settembre 1944 venne arrestato dal tenente colonnello Kappler delle SS e tradotto nel carcere di Trieste, poi trasferito nel campo di sterminio di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945, a soli 36 anni.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: A. Picariello, Capuozzo, accontenta questo ragazzo