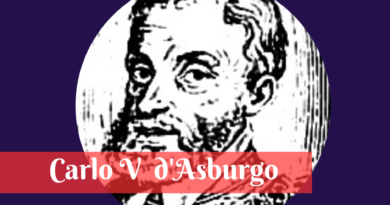Delitti, pene e lavoro riconciliatore nell’Antica Roma
“I delitti, le pene ed il lavoro riconciliatore nell’Antica Roma” è un interessantissimo articolo di Pericle Perali, (Orvieto 1884 – Roma 1949), direttore del Museo archeologico di Perugia ed archivista dell’Archivio segreto vaticano, apparso la prima volta in Rassegna d’Oltremare, luglio 1942 . Volentieri lo proponiamo ai nostri lettori.
***
L’affarista («reus», da «res» = affare) l’egoista («cu pidus, avarus», «pravus», da «privus» =colui che sta solo) il traditore (perduellis, proditor) il violento (da «violens, violator», da «vis») l’uomo dalle azioni spor che («facinorusus», da «facinus, faex») e dalle storture («praevaricator» l’imbarazzatore («nocens», da «nectere») , che arrestava il celere svolgersi dell’attività sociale («scelestus», da «scelus; cfr. Greco «skélos»); («celer, cillere», Greco «killo» = accelerare), l’infiacchito ed impacciatore («malus», da «malacia») mancavano contro il «fas» il «ritus» il «pactum» la «pax» lo «ius» lo «iussum» l ‘«aequitas» i «mores» i «vadimonia» la «fides» il «foedus» la «pietus», erano perfidi rompitori dei legami («perfidus», «da fides») erano ribelli alla «disciplina», che regolava la convivenza sociale e le responsabilità tecniche giuridiche e morali . Chi, per egoismo («cupiditas, avaritia, pravitas»), osa va il discioglimento («delictum») da quegli obblighi e faceva violenza contro di essi («violatio»), e li indeboliva e li impacciava («maleficium») – compiendo un’azione sporca («facinus»), una stortura («praevaricatio») col proprio sviamento («vitium» , da «vitus», «vitare») produceva a se stesso intralci («noxae») e legami punitivi («sanctiones») ed insieme si meritava danni («damnum, damnare») e violenti rivalse («vindiciae, vindictae») dal la comunità dai soci e dai cittadini.
Se si trattava di un leggero sommovimento, di una lieve macchia o d’una azione un po’ sporca («peccatum», da «pix, piceus, fucus») ed anche solo d’un intrigo («crimen»), bastava rimettersi in sesto nei propri li miti («castigare») , e bastava pulirsi («purgare»).
Se si trattava, ad esempio, di «aes alienum», cioè di metallo altrui o non rifinito da restituire («debitum»), e se mancava chi desse un risarcimento per la mancata restituzione («vindex») o facesse garanzia («vas, vadimonium»), se mancava chi, speranzoso nelle future possibilità del debitore, promettesse per lui («sponsor, expromissor»), il «corpus», cioè l’assieme dei beni del debitore stesso o della corporazione cui egli apparteneva, veniva ripartito in proporzione al credito («plus vel minus secanto») tra i creditori insoddisfatti («secare, si vellent, ac partiri corpus addicti permiserunt»).
Lo stesso Aulo Gellio, che, circa sei secoli dopo la promulgazione delle leggi delle XII Tavole, trasmetteva queste notizie con l’inesatta interpretazione dello smembramento del debitore — suggerita evidentemente da influenze antiromane proprio lui, romanamente sincero e coscienzioso, ci attesta di non aver mai in realtà letto né udito che alcuno fosse stato anticamente dismembrato e fatto a pezzi a causa dei suoi debiti («dissectum esse antiquitus neminem equidem legi neque audivi» GELLIO, 20, 1, 52 ), aggiungendo che la lunga età trascorsa aveva obliterato le parole e i costumi abituali, da cui era reso anticamente comprensibile il senso delle leggi («longa aetas verba atque mores veteres obliteravit, quibus veibis moribusque sententia legum comprehensa est» – GELLIO, 20, 1, 6).
E dunque che legge sarebbe stata quella incisa nel bronzo delle xii Tavole, se era destinata a non venir mai applicata, mentre i debiti, basati in Roma sul fido («fides») , erano la forza e la piaga d’ogni giorno, il fulcro della collaborazione ed insieme la causa perenne delle contese tra patrizi e plebei , tra padroni ed operai?
Così, per la nostra interpretazione, rientra nel notissimo sistema romano della cessione dei beni («bonorum cessio»), fatta dal debitore ai creditori, torna al suo valore ragionevole e socialmente utile quel testo, che solo influenze antiromane avevano potuto offuscare.
Se invece si trattava di lesioni, anzi proprio di fratture («si membrum rupit») , e se le membra spezzate non si risaldavano fra loro ridivenendo compatte («ani cum eo pacit»), il lesionatore doveva risarcire il lesionato per mezzo d’una «taglia», cioè con un continuo a appoggio» a sostegno e ad aiuto nel lavoro (greco «tálas, télamon » = sostegno; « tollere » = sostenere) come appunto disponeva la legge («talio esto» – FESTO : «talionis»).
Così torna al suo valore originario e ragionevole quel testo delle XII Tavole, lasciando alla barbarie antiromana la cosiddetta «legge del taglione», la quale comunemente s’interpreta: «occhio per occhio, dente per dente» avrebbe avuto il risultato antieconomico ed antisociale d’accrescere e non di risarcire il danno comune , storpiando anche il lesionatore, mentre la saggezza romana esigeva, quanto più possibile, la conservazione e non la distruzione e la soppressione di forze lavorative.
D’altronde, sia la presunta «dissectio corporis» del debitore , sia l’applicazione del presunto «taglione» , avrebbero richiesto il continuo e delicatissimo funziona mento d’un inverosimile «collegio di chirurgi» per l’esercizio legale d’una «anatomia giudiziaria » certamente più sciocca e più futile della malfamata «astrologia giudiziaria» di medioevalistica memoria.
Essendo frammentari i testi, non conosciamo la pena che toccava a chi sradicava o «schiantava» i prodotti del suolo («qui fruges excantassit» – PLINIO , Naturalis historia , 28, 2 , 17) ed a chi trascinasse via («pellexeris») la messe altrui già mietuta («alienam segetem» SERVIO, ad Bucol. , 8, 99).
Comunque, contro l’opinione corrente , che trova in questi passi una pretesa documentazione di pratiche magiche e d’incantesimi sui prodotti agricoli, possiamo ora precisare che si trattava solo di comunissimi reati contro la proprietà e contro il lavoro .
Il medesimo genere di reati ricorre in altre leggi delle XII Tavole con le relative pene.
Si condannava nel capitale («capital esto») — e gl’imponevano di restare obbligato («iubebant necari») ed assoggettato ai lavori obbligatori per l’annona («suspensum Cereri») — chi di notte avesse spianato («noctu pavisse») ed avesse mietuto («ac secuisse») i prodotti ricavati dal suolo col lavoro dell’aratura («frugem aratro quaesitam» – PLINIO, Naturalis historia, 18 , 3 , 12).
E chi avesse incendiato un impianto da lavorarvi col fuoco («aedes») oppure un cumulo di frumento deposi tato presso l’impianto aziendale (a qui aedes acervumque frumenti iuxta domum positum combusserit ») , se aveva commesso ciò scientemente e premeditatamente («si mo do sciens prudensque id commiserit» ), doveva venir legato e frustato («vinctus , verberatus») ed obbligato al servizio di lavoro in un’impresa del fuoco («igni necari»). Se invece lo avesse fatto per disgrazia, cioè per negligenza («si veru casu, id est neglegentia»), si comandava («iu betur») o che risarcisse il danno («aut noxiam sarcire»), oppure, se non era idoneo a ciò («aut si minus idoneus sit») , venisse castigato molto lievemente («levius casti gatur» – Digesto, 47, 9, 9 ).
E, sempre per la legge delle XII Tavole, chi, senza averli contrattati, tagliava alberi altrui, doveva pagare, per ogni albero, 25 libbre di metallo («qui iniuria caeci disset alienas arbores lueret in singulas aeris XXV» PLINIO, Naturalis historia, 17, 1 , 7).
Infliggendogli un «damnum» , cioè col «condemnare» il danneggiatore, si cercava di fargli restituire («ex piare» , da «pijus» = colui che piglia) il mal tolto per risarcire, quanto era possibile, il danneggiato.
Presso i Romani più antichi le «multae» (da «mulge» = «mungere» = spremere) vale a dire le spremute di danaro o «sanguis» , imposte come risarcimento, le con danne sul capitale («capital esto ; damnare capite; capi tali poena afficere») le condanne ai lavori forzati nelle grandi industrie («in sacrum») nelle botteghe artigiane («in insula») e, peggio, nelle grotte dove si torcevano le corde («ad lautumias») o addirittura nelle miniere («saxo», «ad metalla») consistevano sempre in prestazioni supplementari («supplicium, supplere»), cioè in una forzata restituzione in un forzato risarcimento del danno o del reato , con una prestazione gratuita ed obbligatoria o di danaro o di valori materiali o di lavoro più o meno gravoso , ma sempre forzato e riparatore. Ben rare invece erano, nell’antica Roma, l’immobilizzazione l’inutilizzazione la soppressione di lavoratori, per quanto dannosi e malvagi essi si fossero manifestati.
Il carcere («carcer, custodia») i ceppi e le catene («compedes, vincula, catenae») le frustate («virgis, flagris caedere», «verberare» le legature per le frustate « verberibus necare») e , solo eccezionalmente ed in caso di pubblici reati , il taglio della testa per mezzo d’una scure («securi ferire, percutere») erano le progressive pene coercitive ed afflittive dei delitti più gravi, proprio come, in preciso e formale ordine decrescente , le indica va Cicerone quando caratterizzava , di fronte al diritto naturale ed al diritto positivo , il contenuto egoistico ed antisociale («cupiditas, avaritia, pravitas»), che sta al fon do d’ogni reato.
Non è lecito – egli dice procurare il proprio vantaggio col nuocere altrui («non liceat sui commodi causa nocere alteri»). Ed a questo guardano le leggi, questo vogliono («hoc enim spectant leges , hoc volunt»), che resti incolume l’u nione dei cittadini («incolumem esse civium coniunctio nem»).
E quelli che disgregano tale unione («quam qui diri munt») le leggi li reprimono o con la morte o con l’esilio o con la prigionia o col corrispettivo del danno arrecato («eos morte, exsilio, vinculis, damno coercunt – CICERONE, De officiis, 3 , 5) .
Una pena eccezionale era riservata in antico a chi essendone responsabile verso la società per l’ufficio affidatogli — rivelava i segreti delle industrie socialmente esercitate , ed in seguito la stessa pena fu assegnata , per legge , ai parricidi , uccisori dei propri pari ed uguali.
Valerio Massimo, trattando del rispettare le obbligazioni («de religione observata», la riporta all’età regia). Il direttore delle industrie tessili («Tarquinius rex») ordinò che, cucito in un sacco venisse affogato il «Duo viro» Marco Tullio , il quale, lasciatosi corrompere («corruptus») aveva dato a copiare («discribendum dedisset») al fonditore Petronio («Petronio sabino») un libro con tenente i segreti delle industrie socialmente esercitate («librum secreta civilium sacrorum continentem») e affidato alla sua custodia («custodiae suae commissum») .
Questo genere di supplizio ( « supplicii genus ») dopo molto tempo fu assegnato per legge agli uccisori dei propri pari («parricida» , da «par» + « caedere»). E giustissimamente, perchè con una rivalsa di pari violenza (pari vindicta) si deve espiare la violenza contro coloro che devono obbedire («parentes», da « parere » = obbedire) e la violenza contro i promotori attivatori e sostentatori delle industrie ( « parentum ac deorum violatio ex pianda est » – VALERIO MASSIMO, 1 , 1 , 13).
Ma i tralignamenti individuali, il dissolversi dell’interiore «coscientia», che si riverbera nel dissolversi del l’esterna e sociale « conscientia», verso la fine della Re pubblica, sfociarono nelle atrocità delle proscrizioni.
Eppure la triste consuetudine di costringere al suicidio i sopraffatti, i vinti delle competizioni politiche, nei tem pi delle peggiori infamie e delle più bestiali crudeltà , for se rivelava un ultimo residuo un barlume di rispetto e di compassione verso la personalità dello sconfitto , che do veva scomparire per sempre dalla scena della vita.
D’altra parte però non può dimenticarsi un’esplicita affermazione di Tito Livio , il quale aveva assistito da giovinetto alle proscrizioni, che ebbero anche Cicerone fra le loro vittime.
Chiudendo la narrazione della pena esemplare e crudele inflitta anticamente a Mezio Fufezio per il vile tra dimento da lui perpetrato sul campo di battaglia contro l’esercito dei Romani suoi alleati, Livio affermava che quello era stato il primo ed ultimo (supplicium in cui parve che i Romani avessero dimenticato le leggi del l’umanità , mentre, al confronto d’ogni altro popolo, ave vano sempre preferito per le pene più miti (Livio, I , 28, 11).
Infatti per il peggiore dei rei, per il traditore della società e della patria (perduellis»), la pena consisteva in una specie di morte civile , non nella morte fisica.
Lo eliminavano dalla convivenza della società , o sbalzandolo fuori della città con l’esilio («exsilium» , da «ex silire» = balzare fuori), oppure togliendogli il modo di lavorare e di vivere del suo lavoro. Gli veniva interdetto l’uso dell’acqua e del fuoco («aquae et ignis interdictio»), cioè gli si vietava l’uso delle due forze naturali , contrarie fra loro , ma ambedue indispensabili promotrici attivatrici e sostentatrici dell’industria («duo discordes ignis et unda dei» – OVIDI , Fasti, 4,788 ).
Questo criterio fondamentale della tradizione giuridica romana intorno alla spassionatezza ed alla mitezza delle pene e delle punizioni è affermato da Cicerone.
Ogni rimprovero , ogni castigo deve esser privo di atteggiamenti oltraggiosi («omnis animadversio et castigatio contumelia vacare debet») . Si deve evitare che la pena sia maggiore che la colpa («a cavendum est ne maior poena quam culpa sit»). Soprattutto si deve frenare l’ira nel punire («la prohibenda maxime est ira in puniendo» – CICERONE, De officiis, 1 , 25) .
Nel 568 di Roma si svolsero numerosi processi in base al celebre «Senatus consultus de Bacchanalibus» , per reprimere in Roma e nel resto d’Italia ed eliminare l’eccessiva diffusione delle imprese a catena promosse dalla grande industria canapiera ellenica , che, coi cosiddetti culti bacchici o dionisiaci, aveva attratto nella sua orbita soffocatrice e depravatrice l’Etruria , la Campania e gran parte della stessa Roma ( 2 ).
Anche allora però, per il maggior colpevole, per Minio Cerrinio Campano, la pena fu soltanto l’esilio la ben vigilata prigionia ad Ardea, perchè non fuggisse ne riuscisse ad uccidersi («Ardeam in vincula mittendum… intentiore custodia, non solumne effugeret, sed ne mortis consciscendae locum haberet»), mentre ai minori re sponsabili fu confiscato il capitale («capitali poena af ficiebant»).
Molti di costoro furono anche messi ai lavori forzati («plures necati» , da «nexus, nexum») piuttosto che gettati in catene («quam in vincula coniecti sunt» – Livio, 39, 18,5 e 19,2) .
Poco più d’un secolo dopo, nel 688 di Roma, alla scoperta della congiura di Catilina , il console Cicerone seguì due diversi criteri nei riguardi dei congiurati.
Affinchè risultasse manifesta la colpevolezza di Cati lina, invece di farlo arrestare e condannare, investendo lo , in Senato, con le sue terribili invettive , lo suggestionò e lo costrinse a disvelarsi appieno, a fuggire da Roma, a raggiungere l’esercito già pronto per la ribellione.
Al contrario, fece arrestare i complici di Catilina, e in accordo col parere dei consolari e di Catone, ma in contrasto col parere di Quinto, suo fratello , e di Giulio Cesare — sostenne in Senato che si dovessero subito giustiziare, perchè di loro stessa volontà s’erano fatti estranei alla «civitas» , dichiarandosi nemici della «patria». Eppure Giulio Cesare per salvarli s’era esplicitamente appellato all’antica procedura della confisca del capitale , dell’esilio e della prigionia in città municipali.
I congiurati vennero messi a morte. L’insolita severità del Senato allora procurò a Cicerone, che l’aveva suggerita, il merito d’esser riconosciuto per salvatore del la patria. Subito appresso, però, ripresero il sopravvento i sovvertitori , i quali riuscirono a farlo esiliare.
Nel fluttuare delle vicende rimase sempre ferma in Roma un’intima connessione tra le sanzioni del diritto penale positivo e certe sanzioni , ad un tempo morali ed economiche , di diritto naturale . Infatti ai risarcimenti di lavoro forzato , alle multe , alle confische , alle coercizioni punitive comminate dalle leggi e applicate nei giudizii, per punizione del reo s’aggiunge va, da parte di ciascun cittadino , il proposito di escludere dalle attività industriali («neminem in contione stare, qui… non sit exsecratus») e dalle garanzie dei contratti («detestatusque») i suoi capitali , i suoi impianti ed i suoi apporti sostenitori («caput domum fortunasque»).
Persino si sollecitavano da tutti contro il reo (« quisque precatus sit ) gli sdegnati promotori attivatori e so stentatori della vita sociale («iratos deos») , i quali però non prendevano mai l’iniziativa contro i ribaldi («num quam deos ipsos admovere nocentibus manus») . Era già molto che, al momento di ricambiare il reo con le meri tate rivalse , attrezzassero contro di lui i danneggiati («satisesse», in occasione ulciscendi, laesos arment» Livio, 5 , 11 , 15-16 ).
In tal modo il reo , il colpevole veniva reso improduttivo («infelix»).
Questo toccò , nel 353 di Roma, a Lucio Virginio ed a Marco Sergio , due tribuni militari , che , contendendo tra loro per reciproca invidia e gelosia , avevano causato un grave disastro nella guerra contro Veio e contro i Cape nati ed i Falisci (Livio, 5, 8) .
Infatti , quando la massa operaia li ebbe condannati ambedue ad un risarcimento di diecimila libbre di metal lo non lavorato («plebs denis millibus aeris gravis reos condemnat »), Lucio Virginio invocava ( «deprecante» che con quella fortissima multa non lo si rendesse più improduttivo («infelicior») nelle sue attività aziendali di quello che era stato improduttivo nella milizia («ne in felicior domi quam militiae esset» – Livio, 5 , 12 , 1).
Così dunque l’isolamento dal plesso sociale ed i dan ni punitivi rendevano improduttivo («infelix») il reo ed inadatto («ineptus») e squilibrato ( «iniquus», da «ae quus») e perciò incapace di lavorare e di raggiungere i suoi scopi («non satis compos sui») .
Di sua volontà egli si era isolato («pravus») si era fatto discorde («discors») si era messo nell’impossibilità di pigliare aiuto dallo stesso ambiente di forze sociali in mezzo al quale e per virtù del quale viveva («impius» = colui che non piglia) .
Perciò era necessario che egli stesso volenterosamente disciogliesse («luere, solvere») l’intrigo in cui si era messo («poena», cfr. Greco «peníon» = filo raccolto sul rocchetto con molti giri; «luere, solvere poenam») .
Doveva cioè restituire («expiare») e supplire ( «supplicium», da «supplere»). Solo per questa via avrebbe potuto riacquistare il doveroso necessario equilibrio («ae quitas») e, pagatone il fio («venia», da «venum ire»), poteva sperare che il suo fallo venisse dimenticato («ignoscere»).
E ciò non raramente avveniva presso i Romani, perchè essi molto confidavano e speravano nella resipiscenza («emendatio temeritatis» = ricompramento delle sconsideratezze od ebrietà), perchè contavano molto sul gran de apprezzamento («timor , cfr. Greco «timáo» = valutare), che facevasi delle forze fisiche psichiche e spirituali, promotrici, attivatrici e sostentatrici della vita sociale («timor deum»), soprattutto per il timore di perder ne il favore e l’aiuto nella necessaria ed obbligatoria fatica del lavoro quotidiano.
Ed infatti quando a rivalsa di tutti i prevaricatori e di tutti i tralignamenti , si legge il proemio di Livio nel le sue storie si è costretti a riconoscere che una trentina d’anni prima della nascita di Cristo, non poteva meglio rivelarela saldezza delle sue basi antiche una civiltà pagana, già molto deviata dai suoi ben regolati primordii, ma tuttora capace di riattingervi forza per la sua volontà di redenzione.
Quella pagina liviana ed insieme con essa molte pagine di Cicerone e di Sallustio sono espliciti documenti dell’originaria spirituale nobiltà dei Romani, tanto civili e tanto filosofi da saper fare l’esame di coscienza sulle deviazioni della loro vita pubblica e privata , da sa per gridare pubblicamente il «mea culpa» , da saper ascoltare come inizio alla narrazione della loro grande storia un accorato richiamo a ricredersi a riassettarsi nel proprio traviamento, a redimersi per una via d’espiazione e di rigenerazione.
Nessun rigoroso ma equanime moralista dopo rilette le esemplari pagine precristiane di Cicerone di Sallustio e di Livio – potrà mai più ripetere né tollerare le false o tendenziose notizie le calunnie d’ogni genere, che l’astio dell’antica e della moderna antiroma ha divulgato e divulga per negare per nascondere o per offuscare la vigorosa operosità, la prudente saggezza e la scrupolo sa rettitudine dei nostri progenitori italiani e romani.
Ognuno saprà porre a carico dell’umana fragilità i tralignamenti ed a vantaggio dell’umana coraggiosa coscienza morale la romana confessione, il romano penti mento delle colpe ed il rom’no proposito d’espiarle per mezzo di risarcimenti e riparazioni, supplendo al danno ed al delitto con un sacrificio dei beni e dei risparmi o con la pena – obbligatoria e talvolta forzata – del lavoro ricompratore e riconciliatore.
( 1 ) Perali: Tessili e metallurgi nel Foro Romano, Roma, 1941 , § 50 , nota 35.
( 2 ) PERALI: Sulla zona archeologica della Farnesina (in Osservatore Romano , 27 f)