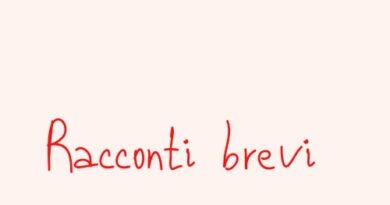Cause della sconfitta del 1866
Lo storico Pietro Silva, in Il Sessantasei edito a Milano nel 1935, indagò sulle cause della sconfitta della Terza guerra d’indipendenza italiana, soffermandosi con lucida analisi sul difficile rapporto con gli alleati, ma soprattutto sulle debolezze di un giovanissimo e ancora sconnesso Regno d’Italia.
***
L’alleanza che aveva unito l’Italia e la Prussia, e che avrebbe dovuto essere cagione di forza, era riuscita, invece, cagione di diffidenza e di sospetto; per fatalità di circostanze, alle quali, bisogna riconoscerlo, né da parte dell’Italia, né da parte della Prussia, si era saputo o voluto reagire, allo scoppio della guerra i due governi si guardavano con malcelata avversione; e questa, durante la guerra, invece di diminuire o di sparire, andò sempre crescendo. Dopo Sadowa, il Bismarck, giunse al punto di non informare più direttamente i suoi alleati delle sue intenzioni e delle sue mosse; e ci lasciò virtualmente isolati, durante il delicatissimo periodo delle trattative, che avrebbero dovuto essere condotte di comune accordo; e alla fine, ottenuti i suoi scopi, ci abbandonò al nostro destino. La prima notizia della conclusione dell’armistizio fra Prussia e Austria, ci giunse non dal campo prussiano, ma da Parigi!
L’azione politica italiana si era esplicata tentennante e malcerta e priva di unità, per i dissidi profondi che mettevano l’un contro l’altro i dirigenti. Si ricordi, come caratteristico fra tutti, il contrasto fra La Marmora da una parte e il Re e Ricasoli dall’altra, nella questione dell’insurrezione ungherese e della diversione in Dalmazia. E il contrasto non si era limitato al campo teorico delle idee, ma si era sentito anche nel campo pratico dell’azione: e così, mentre il La Marmora respingeva le proposte di Bismarck, il Re continuava direttamente a Berlino le trattative per mezzo del Turr, e affrettava col desiderio il giorno nel quale al posto del La Marmora si sarebbe trovato il Ricasoli; il Ricasoli, prima ancora del suo insediamento, e cioè quando ufficialmente il capo del governo era ancora il La Marmora, trattava a nome del governo con i profughi ungheresi; perfino i segretari generali, come il Cerruti, non so peritavano di esercitare un’azione personale, in assoluto contrasto con quella del ministro responsabile. I dissidi funesti, rivelatisi nella direzione dell’azione politica prima della guerra, continuarono durante la guerra, anzi si complicarono e con gli inconvenienti, certo ancor più funesti, che scoppiarono a rovinare l’azione bellica per terra e per mare. Per terra, mancanza di unità di comando, e contrasti violenti tra il Re, La Marmora, Cialdini, e continue minacce di crisi di comando, per dimissioni date e ritirate; incertezze ed equivoci sul piano di guerra; divisione delle forze; paralisi e lungaggini nell’azione. Per mare, un capo inadatto al suo ufficio, inviso alla maggioranza dei dipendenti, un personale poco esercitato e in parte diviso da rancori e da attriti, e anche qui la mancanza di un prestabilito e chiaro piano di guerra.
A tutto ciò si aggiunse l’influenza straniera di Napoleone III, il quale se era incline a secondare le aspirazioni italiane, mirava anzitutto a raggiungere certi suoi fini particolari. Questa influenza, già pericolosa durante la preparazione della guerra, quando, facendosi forte con l’offerta della Venezia, tentò di trattenerci dall’azione, divenne ancor più pericolosa dopo Sadowa, allorché Napoleone, che voleva far cessare la guerra per arrestare i successi prussiani, si trovò ad avere interessi antitetici a quelli dell’Italia, per la quale la prosecuzione della lotta era assoluta necessità…
Ma, alla fine, non si può non fare una constatazione importante: per quanto l’uno cerchi di additare nell’altro il vero responsabile e cerchi di mondare se stesso dagli addebiti gravi, pure nessuno riesce ad apparire completamente immune, d’altra parte, riesce impossibile ricondurre soltanto su uno o l’altro dei capi, il peso esclusivo della responsabilità… La verità è diversa; è quella che fin dal settembre 1866 intuì lucidamente Pasquale Villari, e prospettò nelle memorabili pagine del suo scritto: “Di chi la colpa?”. “V’è in Italia un grande colpevole – affermava il Villari – che ha fatto più male ed ha commesso più errori dei generali, dei ministri, del partito d’azione, delle malve e delle consorterie, e quest’uno siamo tutti noi”. La verità è che le cause profonde dell’infelice esito della campagna, devono ricercarsi, più che negli errori e nelle colpe commesse da questo o da quello dei capi, nelle condizioni nelle quali l’Italia risorta affrontava il cimento…
Nel 1866, la nuova Italia esisteva da cinque anni soltanto; si era costituita attraverso vicende che appaiono ancor oggi miracolose, per la fortuna da cui furono secondate e per la rapidità con cui si svolsero. Ma questa stessa rapida fortuna aveva impedito che si compiesse il lento enorme lavorio di fusione, di integrazione, necessario a creare lo Stato vero, la compagine nazionale, in un Paese le cui provincie uscivano da secoli di separazione e di discordie. L’esercito e la marina esistevano; apparivano anche notevoli suoi quadri; ma risultavano di elementi disparati, non ancora fusi in un organismo omogeneo e temprato, stranieri ancora gli uni agli altri, divisi, a volte in consorterie e clientele rivali. L’immane macchina burocratica del nuovo Stato aveva cominciato a muoversi, ma funzionava in modo irregolare e difettoso, per molti congegni imperfetti; le finanze erano scompaginate, quasi esaurite, dopo i grandi sforzi del 1859-61. E in troppe manifestazioni dell’attività dello Stato appariva la mancanza di compattezza, di concordia, si sentivano sempre vivi gli spiriti regionalistici.
Ricasoli scriveva in una lettera al fratello, il 21 agosto 1866: “Tutti fanno quello che non dovrebbero fare, o non fanno, o fanno male, cioè che dovrebbero fare. Da ciò la nostra presente disgrazia. Gli ufficiali sono tutti diventati uomini politici, la corrispondenza dei giornali è tutta opera dei quartieri generali e dei vari corpi. E’ una completa anarchia. Ecco perché si disfà l’esercito e dirò si disfà anche il Paese. Le piaghe che sono in Italia sono immense e tutte derivano da vizii che infettano la gerarchia alta di ogni ordine e cose”. In queste frasi sconfortate, è ben scolpita la situazione dell’Italia nel 1866: era non un Stato vero, ma quasi soltanto l’apparenza esteriore dello stato; il lavoro per costituire l’organismo interno era appena cominciato, tra difficoltà incredibili. E contro questa Italia, che aveva cinque anni di vita, stava una vecchia Monarchia, organizzata da secoli, forte di tradizioni e di glorie, sostenuta da un’armata e da una amministrazione tra le prime di Europa. In tali condizioni, è giusto parlare soltanto di colpe e di errori di uomini, a proposito degli eventi del 1866? Come era possibile spezzare la resistenza del poderoso avversario; come era possibile far trionfare sulla sua forza tenace il nostro diritto, ancor quasi inerme?
Non cince, ma cinquant’anni erano necessari, cinquant’anni di lavoro perseverante, di sforzi eroici, di sacrifici, perché la nuova Italia potesse svilupparsi a grande Potenza, capace di sostenere e di far trionfare i suoi diritti sulla secolare nemica.