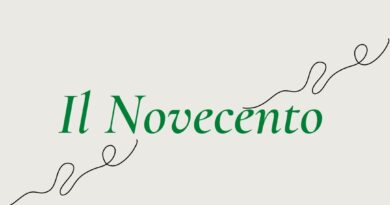Attacco a Dulcigno
I primi movimenti furono diretti a mettere in allerta le fortezze della Morea e ad assicurarsi che Can Hodja Mehmet Pashà, reduce dalla disfatta di Corfù, non sarebbe uscito dai Dardanelli, poi finalmente la flotta veneziana, affiancata da navi della flotta pontificia, dei Cavalieri di Santo Stefano e di quelli di Malta, veleggiò verso Dulcigno, cittadina sulle coste montenegrine, in mano ai turchi. Così iniziò l’ultimo atto della Seconda Guerra di Morea.
L’antica Olchinium, sottratta ai veneziani nel 1571 da Achmet Pashà, era divenuta un covo di corsari e un’importante mercato di schiavi. Apparve loro ben fortificata. Di supporto si stavano muovendo duecento cavalieri croati sotto il tenente colonnello Pellegrini, ma furono attaccati e Pellegrini fatto prigioniero. Lo sbarco avvenne il 23 luglio. Sotto la guida del maresciallo Schulemburg, dieci mila uomini occuparono le alture circostanti, aprirono trincee e posizionarono le artiglierie. Andrea Poletti in Storia della Repubblica di Venezia scrive: “…giunsero a vista di Dulcigno nella notte de ventitre di Luglio, prendendo terra alla spiaggia a Levante due mille Terrritoriali di Dalmazia, poi le genti venute dal Levante, ed il Maresciallo. Saliti i Dalmatini sopra la punta Girana scacciarono i nemici da posti piantando le insegne al Borgo Orientale nel tempo, che l’altre Truppe vi giunsero per la pianura. Occupato dopo qualche resistenza il Borgo Occidentale, restò chiusa da ogni parte la Piazza, guadagnati i Colli dalle Milizie pagate, dandofi principio alla linea di circonvallazione alla parte dritta, perchè più esposta agl’insulti de Turchi accampati in poca distanza”.
Il centro era protetto dagli spalatini, i borghi dal colonello Medin, due batterie stavano piantate contro la muraglia verso est e nord. Rifiutata un’intimazione di resa, si aprì il fuoco. Il Guglielmotti così descrive le operazioni in Storia della Marina Pontificia: gli ultimi fatti della squadra romana da Corfù all’Egitto: “…quattro batterie di breccia a metter giù la fronte di due baluardi contigui sull’istmo; quattro mortaj a lanciare bombe nel mezzo; e due galere per turno a rincarare la dose dalla parte del mare. Andavano esse la sera a prender posto vicinissimo nella cala, facevano nella notte diligentissima guardia perchè niuno entrasse nè uscisse, e il giorno tiravano cannonate al punto assegnato d’accordo col campo. Pigliavano ancora quel che veniva scaraventato dagli arrabbiati dulcignotti: ma niuno mi dice di morti o feriti. Solanto ho trovato una nota di avarie, stimate dal nostro capitan Calcagnini di scudi tre mila. Battuta in tal modo costantemente la piazza, veniva riducendosi agli estremi. I pezzi scavalcati, le difese cadenti, le muraglie rotte, gli animi abbattuti non lasciavano di là altra lusinga che del soccorso richiesto istantemente al pascià dell’Albania…”.
I soccorsi arrivarono il 29 luglio. Un’ondata di cavalieri si abbatté sulle fanterie veneziane costringendole alla ritirata. Tuonarono i cannoni delle navi cristiane nella rada e la cavalleria nemica disparve tra i monti. Il contrattacco musulmano si ebbe il 2 agosto. Duemila turchi assalirono la postazione di Tommaso Sigoreo ai piedi delle colline a settentrione, ma le trincee ressero e il soccorso di Schulenburg seminò morti e impose al Pashà di parlamentare la resa.
Andrea Pisani avrebbe certamente ottenuto una completa capitolazione se non fosse giunta la nuova del trattato di Passarowitz col quale l’Austria, attaccata a sorpresa dalle truppe spagnole in Sardegna, aveva imposto la pace. “Consumarono più giorni le precauzioni credute necessarie per guardarsi da nemici in paese pieno di boschi, ma consistendo nella celerità la speranza del buon fin dell’imprefa, fu fatale qualunque ritardo e la novella della pace conchiusa; in tempo, che potevasi confidare vicina l’espugnazione della Piazza rese sfortunato l’assedio, e lagrimevole la ritirata del Campo”, così commentò il Poletti. Con grande sorpresa gli assediati videro allora issare nel campo veneziano una bandiera bianca.
I turchi tergiversarono, vollero attendere le comunicazioni ufficiali da Costantinopoli o forse tramare un attacco inaspettato, ma il 4 agosto un tremendo fortunale disperse i navigli veneziani. Andarono perse tutte le piccole parche e quattordici galeotte, morirono quattrocento uomini. I sopravvissuti, rifugiati sulla spiaggia, furono preda delle violenze degli assediati che uscirono per approfittarne. Nel frattempo si configurarono le pretensioni dei turchi: volevano tutte le artiglierie, solo allora avrebbero sospeso le ostilità. Il colonnello Alberti, che stava parlamentando, non lasciò risposte e ordinò un rapido imbarco. Molto dopo emissari turchi accettarono di sospendere le ostilità e chiesero uno scambio di prigionieri. Una possibile conquista si era trasformata in una disavventura.
Le sortite degli assediati continuarono anche di notte, per terra e in mare. Provarono ad impedire l’imbarco e caddero trecento soldati e trecento ufficiali, tra i quali il maggiore Morosini e il capitano Craina, fino a quando Schulenburg riuscì a compattare le sue fila e ad aprirsi un varco per abbandonare quell’inferno.
Autore articolo: Angelo D’Ambra