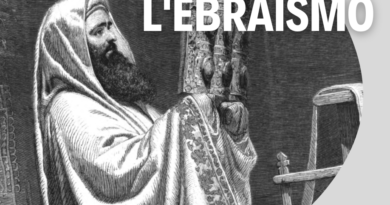Ankon, l’Ancona greca
Ankon, l’Ancona greca, nacque nell’ampia insenatura che, “a gomito” (ank significa proprio questo), si protende dal Colle Guasco e definisce uno scalo marittimo naturale nell’Adriatico, ben protetto dai venti. Il sito fu un ponte tra Occidente e Oriente, nodo di scambi culturali e commerciali tra popoli differenti, e nel 387 conobbe l’insediamento dei greci siracusani di stirpe dorica divenendo una delle polis più a nord della colonizzazione greca in Occidente.
Sicuramente nella seconda metà del VI secolo a.C., Ankon era parte di una estesa rete di piccoli scali greci, costituiti probabilmente solo da attrezzature portuali e magazzini, sui quali si incentrava l’attività commerciale attica in quello spicchio di Mediterraneo. Ancona si trova infatti sulla rotta seguita dalle navi provenienti dalla Grecia. La rotta partiva da Iader, l’antica Zara, era la più seguita dai commercianti dell’Egeo che risalivano la costa illirica e poi si proiettavano in Italia. Essa attraversava il mare aperto nel tratto più favorevole, appunto a Zara, dove minore era la distanza da superare per raggiungere la costa occidentale e dove il monte Conero offriva un sicuro punto di riferimento per la navigazione a vista.
Ma Ankon rappresentava pure un importante punto di penetrazione nell’entroterra piceno. Da qui i prodotti attici potevano essere scambiati con le popolazioni italiche. Ad Ankon i greci di Rodi, Focea, Corinto, Egina e Atene vendevano olio e vino e si rifornivano di grano. Dallo scambio con prodotti manifatturieri, in specie oggetti in bronzo e ceramiche, l’artigianato piceno restò profondamente influenzato e visse un lungo periodo orientalizzante.
Intorno al IV secolo la presenza attica fu soppiantata da quella siracusana diretta da Dionigi il Vecchio. Ce lo dice Strabone (5,241): “Ancona, città greca, fondazione di Siracusani esuli dalla tirannide di Dionigi”. Dionisio si liberò dei suoi oppositori relegandoli ad Ancona, ma al contempo li legò a sé affidando loro la colonizzazione dell’area. I fuoriusciti siracusani trovarono un prospero porto, ottime condizioni climatiche, ma soprattutto numerose sorgenti, elemento indispensabile per lo stanziamento.
Sulla sommità del Guasco sorse l’acropoli ma della colonia siracusana non ci sono molte testimonianze urbanistiche o architettoniche. Ad inizio Ottocento furono scoperte, ai piedi del Guasco, strutture in opera quadrata e frammenti di colonne scanalate e provviste di intaccature circolari. L’individuazione di tratti di mura, delle fondazioni di un’area sacrale dedicata ad Afrodite euplea, protettrice dei naviganti, e di tombe completa ad oggi i ritrovamenti.
Nello stesso periodo sorse un herron dedicato a Diomede, un edificio sacro che era dedicato ad ecisti ed eroi onorati dalla comunità. Il tempio sarebbe sorto sulla riva del mare e appare rappresentato nella Colonna Traiana, ma l’unica testimonianza resta Pseudo Scilace (Periplo, c. 16): “Dopo i Sanniti c’è il popolo degli Umbri, presso i quali si trova la città di Ancona. Questo popolo venera Diomede come proprio benefattore, e c’è un tempio in suo onore”.
Tra gli oggetti di corredo trovati nelle sepolture predomina materiale ellenistico di importazione, anfore prevalentemente di Rodi, monete di Sicione, di Tolomeo Epifane e Corcia, e si è così ipotizzato che l’attività commerciale di Ancona fosse interamente orientata al bacino orientale del Mediterraneo.
Con l’impegno di Siracusa l’emporio crebbe in una città di lingua, cultura ed aspetto greco, tutte caratteristiche che Ankon tenne anche quando divenne romana.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: S. Sebastiani, Ancona: forma e urbanistica; L. Braccesi e M. Luni, I Greci in Adriatico