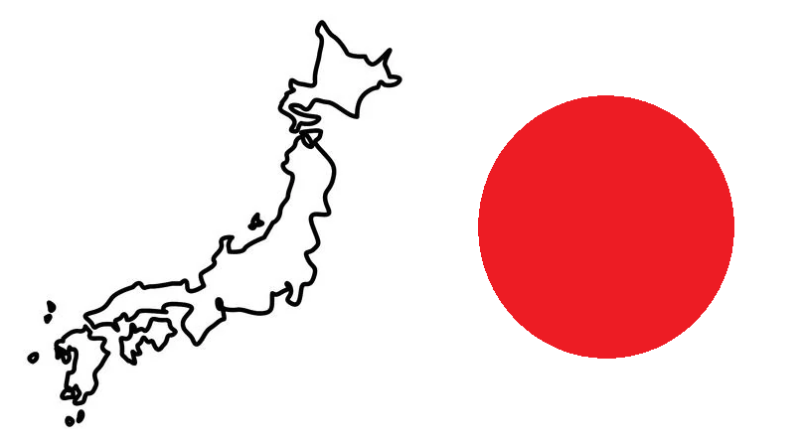Addestramento e crimini di guerra delle forze armate nipponiche
Nell’analisi della condotta delle armate nipponiche nel corso della Seconda Guerra Mondiale colpisce la brutalità di operazioni sui civili in Cina, ma anche l’addestramento efferato, sia fisico che morale, a cui furono sottoposte. Il razzismo che le pervadeva costituì la base della Politica dei tre tutto: “uccidi tutti, brucia tutto, saccheggia tutto”. Nei racconti di Takeshi Maeda, Masayo Enamoto e Hajime Kondo c’è tutta la follia della guerra.
La Marina, prima della guerra, era ossessionata dalla creazione di un piccolo corpo d’elite di aviatori, e i criteri di selezione erano rigorosamente rigidi. Meno dell’un per cento degli aspiranti YOKAREN (tirocinanti al corso di preparazione per aviatori navali) passava l’esame scritto iniziale e molti dei pochi fortunati che superavano quella scrematura sarebbero stati in seguito eliminati durante rigorosi esami fisici. I pochi selezionati che rimanevano venivano inviati all’addestramento di base.
Ogni giorno cominciava con una sveglia alle 05.00, seguita da una forzata immersione nell’acqua fredda. Le reclute si precipitavano sul terreno di parata, si inchinavano in direzione del palazzo imperiale, recitavano un giuramento di lealtà all’imperatore ed erano condotti attraverso una routine di esercizi punitivi. Ovunque, in tutta la giornata, ci si aspettava che corressero, non camminassero.
I pasti erano spartani, consistenti di riso con orzo, o la zuppa misto e verdure in salamoia, occasionalmente un po’ di pesce o carne
Le esercitazioni sul terreno di parata e l’addestramento di base al combattimento si alternavano all’istruzione in aula in matematica, scienze, ingegneria, lettura e scrittura. Tutti dovevano mantenere una media di voti minima o affrontare l’espulsione, e la posizione della classe veniva sempre determinata dal rango accademico. Dormivano in amache appese sulle pareti delle loro baracche.
Takeshi Maeda, che avrebbe pilotato un aerosilurante alla battaglia di Midway, passò con i compagni di corso diverse ore nella Baia di Tokyo a remare su una barca aperta affrontando tutte le condizioni atmosferiche. Maeda ricordò che “a causa dello sfregamento tra il mio corpo e il sedile , i miei pantaloni erano pieni di sangue. Dopo che la tua carne si infettava e produceva pus giallo… sarei andato all’infermeria, e lì curarono le mie ferite applicando unguento e garza. Il giorno dopo, quando feci un addestramento su un cutter, la stessa cosa sarebbe nuovamente accaduta, le mie vecchie ferite si sarebbero riaperte, il che fu molto doloroso”.
La brutalità era il fattore alla base di questo duro addestramento.
Le reclute erano sottoposte ad un’incessante brutalità dagli studenti dell’ultimo anno, istruttori ed ufficiali. Qualsiasi infrazione, mancanza, risposta sbagliata o lamentela portava una immediata punizione, che andava da uno schiaffo sulla guancia ad un improvviso pugno in faccia sino ad un selvaggio pestaggio con una mazza da baseball. Una recluta poteva essere costretta a stare in punta di piedi per un ora o più, o stare rigidamente sull’attenti quando un sottufficiale lo colpiva ripetutamente in faccia o a chinarsi mentre il suo tormentatore li percuoteva ripetutamente sul culo con un bastone.
Calci e pugni spesso continuavano dopo che un uomo era caduto a terra.
Né lamenti né lacrime erano permessi. Spesso un’intera squadra era sottoposta ad un brutale pestaggio per le presunte trasgressioni di qualcuno. Se qualche osso fosse stato rotto, l’uomo ferito veniva mandato all’ospedale e una volta curato, sarebbe stato riammesso al corso successivo.
Saburo Sakai, che divenne il più celebre pilota di caccia della guerra del Pacifico, una volta fu trascinato fuori dalla sua amaca nel cuore della notte e picchiato di fronte ai suoi scioccati compagni di corso mentre si stropicciavano gli occhi per il sonno. Il sottufficiale costrinse Sakai a chinarsi “con questo avrebbe fatto oscillare un grosso bastone di legno e con ogni oncia di forza che aveva lo avrebbe sbattuto contro il mio sedere rovesciato. Il dolore era terribile, la forza dei colpi incessante. Non c’era alcuna scelta eccetto che stringere i denti e lottare disperatamente per non urlare. A volte contavo fino a quaranta tremendi colpi sulle natiche. Spesso svenivo per il dolore. Tuttavia, la perdita di coscienza non costituiva una via di scampo. Il sottufficiale gettò un secchio di acqua fredda sulla mia forma prostrata e mi urlò di riprendere la posizione, dopo di che continuò la sua disciplina fino a quando fu soddisfatto che avrei riparato l’errore a modo mio”.
Dopo aver visto un suo compagno di corso sottoposto ad un simile pestaggio, Takeshi Maeda ricorda di aver provato un’ondata di amarezza: “Come ha potuto un essere umano colpirne un altro con una mazza da baseball?”.
Anche un altro veterano dell’esercito imperiale giapponese, Masayo Enamoto, ricordò che i suoi istruttori erano soliti picchiare tanto lui ed i suoi compagni di corso durante l’addestramento di base che le braccia dolevano, e alla fine della giornata non avevano più energie per colpirli. Come conseguenza gli istruttori trovarono un nuovo modo di mantenere la disciplina – l’autopunizione. Enamoto rammenta: “Una volta che gli istruttori si fossero stancati di picchiarci, ci avrebbero messo gli uni davanti agli altri e ci avrebbero fatto schiaffeggiare. Così noi reclute, compagni tutti insieme, iniziammo a prenderci a schiaffi, invece di essere presi dall’istruttore. Gradualmente, sentii che avrei perso qualcosa se, di notte, non fossi stato picchiato almeno una volta”.
Se alla brutalità implicita nell’invio di uomini armati destinati a uccidersi l’un l’altro su vasta scala si aggiunge l’influenza di stereotipi razziali negativi profondamente radicati, è assai più probabile che la trama delle convenzioni e regole di guerra sia intenzionalmente infranta da ambo le parti.
Masayo Enamoto dice: “Mi venne insegnato che avremmo dovuto disprezzare i cinesi. Erano di una condizione inferiore ai giapponesi e che avremmo dovuto trattarli come animali. Questo fu qualcosa che mi fu insegnato nell’esercito, ed io ci ho creduto, e come risultato facemmo un sacco di male”. Enamoto cominciò il suo addestramento in Cina sparando ai prigionieri. Lui ed i suoi compagni avrebbero legato cinesi ai pali, e poi li avrebbero usati per fare pratica di tiro. “Provammo a sparare al cuore ed io ebbi successo, ma i miei colleghi qualche volta colpirono l’addome ed altri parti del corpo. Non ebbero molto successo. Così un singolo contadino poté essere colpito da dieci o venti persone”, scrisse. Il suo stato emotivo mentre sparava a questi inermi esseri umani era semplice: “mi sentii come se uccidessi solo degli animali, come maiali. E quando il caposquadra chiese a chi piacesse andare per primo alzavo sempre la mano. E pensai che questo fosse il modo in cui l’esercito imperiale giapponese facesse le cose. Io ero totalmente convinto”. Enamoto era un giovane ambizioso e quando seppe della conquista giapponese della Manciuria, si arruolò e fu entusiasta di darsi da fare. Non importava quale fosse il compito, voleva essere il “primo in tutto”. Persino dopo essere stato nominato sottufficiale ed istruttore militare il suo modo di pensare non cambiò affatto: “Una volta, mentre addestravo i miei studenti, entrai nella casa di un contadino cinese e lo aprii con un coltello dal petto allo stomaco. Feci a pezzi quel contadino e mostrai ai giovani soldati che i cinesi erano bestie e che loro dovevano fare cose simili”.
Enamoto così come molti soldati giapponesi ammise stupri sistematici ai danni di donne cinesi: “Andavamo nei villaggi cinesi come parte delle operazioni, da soli o insieme, e poi se vedevamo qualunque donna, la stupravamo”. Le donne diventavano anche oggetto di sadismo efferato. Enamoto, una volta, scelse di non stuprare una donna ma, dopo averla cosparsa di benzina, le appiccò fuoco bruciandola viva.
Le “operazioni” dei giapponesi in Cina erano le famigerate azioni di pacificazione della politica dei tre tutto, “Sanko” (cinese: Sānguāng Zhèng cè, giapponese: Sankō Sakusen). I tre “tutto” erano “uccidi tutti, brucia tutto, saccheggia tutto”. Questa politica fu pianificata come rappresaglia contro i cinesi per l’offensiva dei cento reggimenti guidata dai comunisti nel dicembre 1940. Documenti giapponesi contemporanei si riferivano alla politica come “The Burn to Ash Strategy” (Scorched Earth, Jinmetsu Sakusen).
Hajime Kondo prese parte alle azioni Sanko e dipinse una sorprendente immagine della mentalità dei soldati giapponesi che combatterono in questa brutale lotta: “Avevamo la sensazione che nel distretto nemico si potesse fare qualsiasi cosa. Non ci fu detto ufficialmente che avremmo potuto fare qualsiasi cosa, ma lo imparammo dai nostri colleghi più anziani. Fondamentalmente era tutto collegato al sistema imperiale. Siamo cresciuti per uccidere i comunisti e in questa provincia tutti erano comunisti, quindi questa gente avrebbe dovuto essere uccisa per l’imperatore. Questo era il pensiero dei soldati ordinari”.
Questa attitudine “di uccidere tutti i comunisti” ricorda il comportamento dei soldati tedeschi nella guerra contro l’Unione Sovietica. Hitler aveva dichiarato che la guerra della Germania ad est doveva essere di un “tipo differente” da quella combattuta ad ovest. Doveva essere una guerra di sterminio contro i subumani. E i confronti non finiscono lì: per tutti coloro che hanno sentito i veterani tedeschi parlare dei loro attacchi ai villaggi russi sospettati di nascondere “partigiani”, la testimonianza di Masayo Enamoto suona tremendamente familiare: “quando si entrava in un villaggio, per prima cosa si rubava tutti gli oggetti di valore. Poi si uccidevano le persone, poi si appiccava fuoco al villaggio e si bruciava tutto”. Anche i tedeschi non si astennero da stupri, ma i giapponesi lo fecero su una scala maggiore e senza tali scrupoli razziali.
Dopo la guerra, Enamoto fu uno dei pochi giapponesi che rispose per le sue azioni. Fu imprigionato prima dai russi, poi dai cinesi. Fu processato con altri soldati ma, sorprendentemente i cinesi non giustiziarono assassini e stupratori confessi come lui. Invece, alla fine degli anni cinquanta, venne loro permesso di ritornare in Giappone. Quando gli fu chiesto, durante l’intervista, se provasse un senso di colpa, la sua risposta fu sconvolgente: “Non sentivo alcun senso di colpa allora. Perché non aveva alcun senso di colpa allora? Perché sta combattendo per l’imperatore. Egli era un dio. Nel nome dell’imperatore potevamo fare qualsiasi cosa volessimo contro i cinesi. Perciò non avevo alcun senso di colpa”.
Autore articolo: Vincenzo Zazzeri, appassionato di storia militare romana, della Guerra Civile americana e delle due guerre mondiali.
Fonte foto: dalla rete
Bibliografia: John Dower, War without mercy, pp 3-15; Ian W. Toll, Pacific Crucible. War at sea in the Pacific, 1941-1942, pp 95-96; Laurence Rees, Horror in the East, pp 27, 35-36, 50-53.