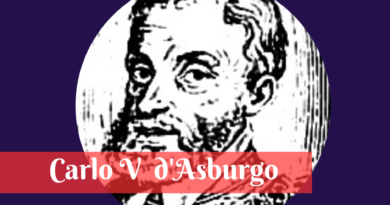Guittone d’Arezzo e la battaglia di Montaperti
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, sono i versi iniziali di una canzone di Guittone d’Arezzo, una delle sue poesie più significative, quella che canta dispiaciuta la sconfitta di Firenze nella Battaglia di Montaperti.
Il 4 settembre del 1260 i fuorusciti ghibellini di Firenze, alleatisi con Siena e le altre città ghibelline di Toscana, aiutati dai cavalieri tedeschi di re Manfredi di Sicilia, misero in rotta, a Montaperti, i fiorentini guelfi. A questa schiera sconfitta apparteneva anche il poeta Guittone d’Arezzo che visse angosciosamente la disfatta, temendo che la vittoria imperiale potesse prostrare definitivamente la potenza del libero comune di Firenze.
Il suo turbamento finì in versi dolenti e appassionati: “Ahi lasso, or è stagion de doler tanto / a ciascun om che ben ama Ragione, / ch’eo meraviglio u’ trova guerigione, / ca morto no l’ha già corrotto e pianto, / vedendo l’alta Fior sempre granata / e l’onorato antico uso romano / ch’a certo per, crudel forte villano, / s’avaccio ella no è ricoverata…”. La canzone piange lo scoramento di Firenze in seguito alla battaglia persa, uno scoramento che è anche depressione morale e mortificazione della giustizia, crollo di una grandezza degna emula di Roma. Il dolore si fa più vivo pensando che Firenze è caduta per il tradimento dei suoi stessi figli, i fuorusciti ghibellini: “Leone, lasso, or no è, ch’eo li veo / tratto l’onghie e li denti o lo valore, / e ‘l gran lignaggio suo mort’ a dolore, / ed en crudel pregio mis’ a gran reo. / E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono / de la schiatta gentil sua stratti e nati…” ovvero “Or non è iù il Leone fiorentino; è come morto perchè gli vengono strappate unghie, detni, valore e suono uccisi i suoi figli più nobili e messi in crudele prigionia in modo molto malvagio. E chi ha fatto tutto questo?”. I nobili ghibellini, cacciati nel 1248. Grazie a loro Siena abbatté il castello di Montalcino, ridusse in suo potere Montepulciano ed ottenne il tributo simbolico, cioè la cerbiatta, versato prima a Firenze dai conti di Santa Fiora in Maremma, come segno di sottomissione.
Guittone produce qui un alto esempio di poesia impegnata e civile, inaugurando il genere della canzone politica che tanto successo avrà in seguito, soprattutto nella poesia di Dante dell’esilio. L’accusa ai ghibellini è forte, hanno venduto la loro città ai nemici senesi e ai mercenari tedeschi per un’effimera vittoria, dovendo anche pagare denaro sonante ai soldati che hanno ucciso i loro padri e figli.
Nella battaglia, vergogna maggiore, furon sottratti ai fiorentini la campana del carroccio, bandiere e armi. Tuttavia lo sconforto si trasforma in ironia e diviene sarcasmo sempre più fiero. I fiorentini sono ora servi dei tedeschi di re Manfredi, gli Uberti e i conti Guidi, principali famiglie ghibelline, non si illudano di averne vantaggi: “Pistoia e Colle e Volterra fanno ora / guardar vostre castella a loro spese; / e ‘l Conte Rosso ha Maremma e ‘l paiese, / Montalcin sta sigur senza le mura; / de Ripafratta temor ha ‘l pisano, / e ‘l perogin che ‘l lago no i tolliate…”. Le vecchie città amiche di Pistoia, Colleva Val d’Elsa e Volterra faranno presidiare i castelli fiorentini a spese loro perchè se ne sono impadronite. E il conte Aldobrandino degli Aldobrandeschi, alleato contro Siena, è ora ben sicuro perchè domina la Maremma. Montalcino non ha più le sue mura di difesa non perché davvero è sicura, ma perché la cinta è stata abbattuta. Pisa ghibellina adesso teme il Castello di Ripafratta, posizione strategica dalla quale i guelfi di Lucca minacciavano i pisani. I perugini temono persino che togliate loro il lago Trasimeno!
Guittone colpisce con feroce irrisione la follia dei fuorusciti, capeggiati da Farinata degli Uberti, che, preoccupati solo di aver vendetta e vanagloria, avevano di fatto causato la rovina politica della loro città, favorendo l’ascesa dell’odiata Siena a proprio danno. Non vi sono compiacimenti stilistici in questi versi. L’impasto linguistico e di stile è disarmonico, ma non disturba, diventa invece un linguaggio scorrevole, ricco di riferimenti precisi ad una realtà pienamnte vissuta con grande pa ssio politica che è pure morale. Il sarcasmo domina ancora nella chiusa: “Baron lombardi e romani e pugliesi / e toschi e romagnuoli e marchigiani, / Fiorenza, fior che sempre rinnovella, / a sua corte v’appella, / che fare vol de sé rei dei Toscani, / dapoi che li Alamani, / avee conquisi per forza e i Senesi”. Firenze chiama alla sua corte i baroni di tutta la Penisola per farsi regina della Toscana, soprattutto ora che ha conquistato con la sua forza tedeschi e senesi.
Solo sei anni dopo, nel 1266, con la Battaglia di Benevento, i ghibellini saranno sconfitti e i guelfi rientreranno a Firenze per restarvi.
Autore articolo: Angelo D’Ambra