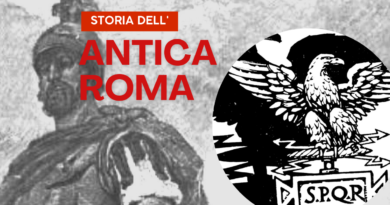Il generale Marsili
Luigi Ferdinando Marsili nacque a Bologna il 20 luglio del 1658. Il suo nome si ascrive di diritto accanto a quelli di Orazio Piccolomini, Raimondo Montecuccoli ed Eugenio di Savoia, generali al servizio dell’impero austriaco. In quegli anni, l’Ungheria, dopo la vittoria austriaca sul fiume Rabà, l’1 agosto 1664, opera del genio militare del Montecuccoli, stava per tornare ad essere teatro di guerra…
Studiò matematica e scienze a Padova e Bologna fino al 1674. Cominciò prestissimo a viaggiare associando osservazioni scientifiche alla raccolta di dati sull’organizzazione militare. Nel 1671, si recò a Napoli dove visitò i Campi Flegrei e salì sul Vesuvio. Nel 1679 si recò a Costantinopoli, allora capitale dell’Impero Ottomano, dove rimase circa un anno.
A ventiquattro anni si arruolò come semplice moschettiere a Giavarino, nelle schiere dei volontari di Enea Caprara, generale di cavalleria, anch’egli bolognese. La volontà di combattere i turchi, di respingerli dalla Penisola balcanica ed allontanarli così dal cuore dall’Europa, lo portò a mettersi in luce nello studiare la difesa della piazza dal lato prospettante il Rabà. Il marchese di Baden restò sorpreso dalle sue intuizioni che pure non si rivelarono utili davanti al nemico che riuscì a travolgere i cristiani sul Rabà. Marsili finì, in tali circostanze, prigioniero e venduto per sei talleri ad Ahmed, pasha di Temesvar.
Adibito ad umili servizi, approfittò della situazione per trarre notizie circa le condizioni militari degli ottomani. Assistette, da schiavo, all’assedio di Vienna ed alla rotta turca di Buda, ed ancora continuò ad indagare sulle artiglierie e le fanterie nemiche, traendo pure una serie di notizie di carattere topografico che, tre anni dopo, serviranno poi al Duca di Lorena, per la conquista della città.
Dopo un anno di prigionia, Vienna ne ottenne la liberazione e tornò ad essere un ufficiale dell’impero. “Benedico le mie catene – scrisse al duca – che, se mi hanno privato di sacrificare la vita per la gloria della Maestà di Cesare, mi hanno reso tuttavia spettatore della costernazione dei suoi nemici, fulminati dalla sua spada. Ciò ha sollevato le mie miserie e dato vigore al mio debole spirito, di rapportare e umiliare, alla notizia dell’Altezza Vostra, tutto ciò che ho potuto raccogliere intorno allo stato di Buda”.
Sul finire del 1683, il Duca di Lorena aveva riconquistato Strigonia e, nella primavera seguente, aveva iniziato la sua marcia su Buda. Il 15 luglio 1684, l’esercito imperiale cinse d’assedio Buda, tenuta dai turchi. Le informazioni ed i consigli del Marsili, che era stato in quella città da schiavo, giovarono molto ai lavori d’assedio, fu però un’epidemia a ritardare le operazioni di guerra. Marsili allora consigliò la costruzione di nuove artiglierie, redasse i piani di difesa di Strigonia e Visegrad e quelli che portarono gli austriaci a togliere agli ottomani il castello di Ersekujavar. Nel 1686 riprese l’assedio di Buda.
In effetti, l’attività di Marsili nell’esercito asburgico consistette prevalentemente nello studio nella progettazione di fortificazioni e altre opere di ingegneria militare quali strade e ponti, nella rilevazione di piante topografiche, e in apprestamenti logistici.
Il 19 di giugno l’esercito imperiale, diviso in due parti, l’una condotta dal duca di Lorena, l’altra dall’elettore di Baviera, comparve sotto le mura di Buda, e presso il castello di Pest. Marsili illustrò il suo progetto d’attacco basato sulla conoscenza che aveva della piazza ed ebbe i consensi del consiglio di guerra. Il 29 agosto 1686, respinta una sortita degli assediati, gli imperiali da tre parti attaccarono la fortezza e vi irruppero. Eugenio di Savoia, alla testa del suo reggimento di cavalleria, assalì il palazzo reale. Si scatenò un orribile saccheggio e molte zone della città finiscono in fiamme, ma Marsili fece l’impossibile per salvare le opere d’arte ungheresi.
Nel 1687 gli austriaci riuscirono a sbaragliare i turchi nella battaglia di Mokacs, che aprì le porte della Schiavonia e della Transilvania, con la resa di Samlio, e la caduta di Agria. Importantissimo successo quest’ultimo cui pure s’accompagnò l’opera del Marsili che fu tra gli inviati imperiali per la trattazione della resa della città. Sul finire di quell’anno stesso, Giuseppe d’Asburgo, primogenito di Leopoldo I, cinse la gloriosa corona di Santo Stefano.
Per ratificare la pace coi turchi, proprio il Marsili fu inviato in Serbia, ma poiché le trattative andavano per le lunghe, il nostro ufficiale si impegnò a presentare una proposta di fortificazione della linea del fiume Morova e del Monte Emo. Combatté ad Emo, fu tra i firmatari della pace di Carlowitz, assieme generale e ambasciatore, uomo di battaglie e diplomatico astuto. Finì però col suscitare la gelosia del Conte d’Arco, accanto a lui per difendere la piazza di Breisach, durante la Guerra di Successione Spagnola. Il dissidio tra i due scoppiò subito. Il conte era convinto che i francesi non avrebbero mai preoccupati di prendere la piazza, il Marsili pensava invece il contrario e sosteneva la necessità di richiedere rinforzi ed avviare lavori di fortificazione. Il Marsili, avviò i lavori per migliorare le difese cittadine, nonostante l’opposizione del conte d’Arco e ciò gli costò gli arresti, ma quando il conte si accorse che il suo ottimismo era ingiustificato e che invece il suo rivale aveva ragione, era ormai troppo tardi chiamò i suoi ufficiali e comunicò la decisione di arrendersi al nemico. Breisach fu consegnata a Luigi di Francia, duca di Borgogna, quasi senza combattere.
Il Conte d’Arco col Marsili si ritirarono a Reinfeld e qui furono posti sotto inchiesta, accusati di tradimento da una corte militare. Il conte fu decapitato. Sullo stesso ceppo fu spezzata la spada di Marsili che ebbe salva la vita ma dovette lasciare l’esercito con disonore, nel 1704. Fu poi riabilitato molti anni dopo, ma non tornò più alla vita militare, si dedicò esclusivamente alla scienza, in particolare alla geologia, all’astronomia e all’oceanografia, nella sua città natale.
Morì il 1 ° novembre 1730 all’età di 72 anni a Bologna lasciando in eredità alla città la sua biblioteca ed una ricca collezione di strumenti, minerali e antiche opere d’arte.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Fonte foto: dalla rete
Bibliografia: T. Chierici, Il conte Luigi Ferdinando Marsili