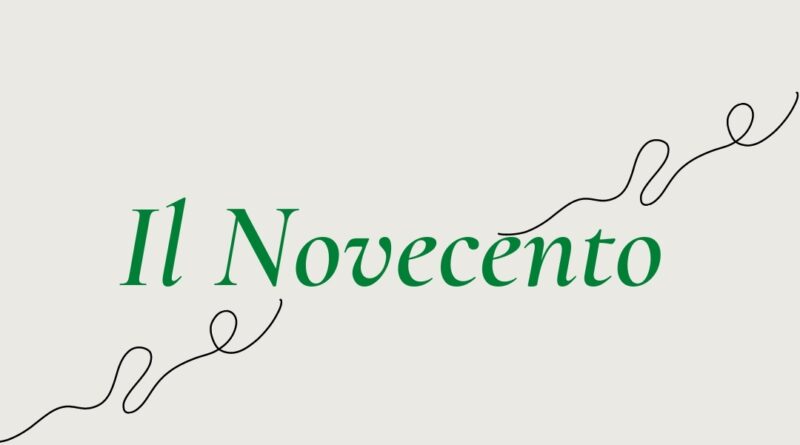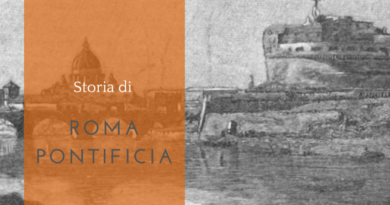Le donne negli anni Trenta
Negli anni del fascismo la famiglia divenne un istituto di carattere politico. Il regime aveva interesse a farne un soggetto pubblico basilare per la conservarvazione dell’ordine e l’esercizio dei diritti politici era interdetto alle donne.
In questo tipo di società, fortemente controllata anche nei suoi comportamenti privati, venivano però zittiti quei diversi protagonismi che già ribollivano. Da questo punto di vista uno dei soggetti principali fu la donna.
Formalmente emarginata dalla politica, la donna non era solo quella della maternità ostentata nelle fotografie ufficiali, era un soggetto pubblico che stentava a trovare altre identità.
Nel 1931 c’erano circa nove milioni di donne addette alle cure domestiche e questo status costituiva la principale aspirazione della popolazione femminile. In questo ambito si potevano individuare diversi profili. Il primo era costituito da una minoranze di donne, abitanti le grandi città, col marito libero professionista o impiegato, una media di 2,5 figli e casalinghe in una famigliadi 4 o 5 componenti. Di queste alcune avevano anche lavorato ma avevano poi rinunciato all’impiego dopo il matrimonio. Il secondo gruppo era quello delle operaie specializzate. Esse lasciavano il lavoro appena sposate per divenire “angelo del focolare”. Poi c’erano le contadine, che in realtà non erano vere casalinghe perchè erano le sole a mantenere l’attività lavorativa anche dopo il matrimonio. Chiaramente la loro condizione era la più faticosa.
In linea di massima la donna era più colta: se nelle scuole secondarie la presenza femminile era stata inesistente, alla fine del decennio coprirà il 21% del totale. L’insegnamento costituiva la maggiore aspirazione delle giovani del ceto medio, ne conseguì che, nel 1933, le vincitrici del concorso a cattedre per la scuola media erano il doppio degli uomini. Tuttavia l’ideale fascista fu sempre quello della donna madre e casalinga.
Nel 1933 Margherita Sarfatti, biografa e amante del Duce che dovette fuggire in Argentina dopo le leggi razziali, ripropose il mito della dea madre col culto della Mater Matuta, di lì a poco la maternità divenne pure il simbolo della continuità della razza. Era questa una retorica che sfociò nel successo di Beniamino Gigli, in un tripudio di retorico sentimentalismo con la canzone “Mamma”.
Il fascismo tese sempre a garantire una preparazionequasi professionale del mestiere di mater familias. Fiorirono cioè i corsi di economia domestica, per le donne di città e campagna, dove si apprendeva a mantenere l’igiene di casa e dei bambini, a organizzare la spesa senza sprechi, a cucinare vivande proteiche ma economiche, a cucire, a preparati surrogati di caffè e sapone… Ed è negli anni trenta che non a caso nacquero alcune delle più famose riviste femminili come Grazia, Gioia e Annabella.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: C. Dau Novelli, Sorelle d’Italia. Casalinghe, impiegate e militanti nel Novecento