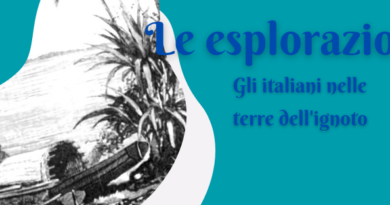La Cirenaica italiana
Dal 1912 la fisionomia della Cirenaica andò profondamente trasformandosi. In particolare Bengasi conobbe uno sviluppo imponente dovuto agli investimenti italiani.
Il vecchio castello cittadino, all’arrivo degli italiani, era decadente e sgangherato. Quando Paolo della Cella, medico della Marina Sarda, vi fece visita nel 1817, lo trovò a pezzi scrivendo: “Il castello del bey è bensì guarnito da nove pezi di cannoni rivolti contro la città, ma il primo guasto lo fanno sulle mura stesse del castello che cadono a pezzi per ogni colpo che esse gittano”. Qualcosa del genere lo raccontò anche Pietro Mamoili nel 1882: “Un giorno stavo sulla spianata del castello chiacchierando con alcuni indigeni i quali, correndo il ramadan, aspettavano il colpo di cannone del tramono per poter, come di rito, rompere il digiuno. Il colpo venne ma in parti tempò crollò un pezzo di torrione che non seppe resistere alla scossa dell’innocuo cannoncino”. Da quel lontano 1882 il castello non era stato in alcun modo ristrutturato. Lo fecero gli italiani e vi insediarono l’artiglieria. In egual modo Bengasi e le città della Cirenaica si destarono dal torpore e si riempirono di operai, di negozianti, di industriali.
La Cirenaica fu popolata da oltre 20.000 coloni italiani, alla fine degli anni ’30, la stessa popolazione di Bengasi era composta da oltre il 35% degli italiani nel 1939.
Nel Cirenaica furono fondati, per i coloni italiani, i villaggi rurali di Baracca, Maddalena, Oberdan, D’Annunzio e Battisti nel 1938, successivamente Mameli e Filzi nel 1939. Per le famiglie libiche furono creati i villaggi di Gedida-Nuova, Nahida-Risorta, Zahra-Fiorita ed el-Fager-Alba. Ogni villaggio era dotato di infrastrutture, servizi sanitari e scuole.
L’occupazione italiana della Cirenaica fu accompagnata anche dall’entusiasmo e dallo stupore per la riscoperta del passato classico di quella terra. Sui giornali si parlò di Cirene al tempo dei greci e dei romani, della scuola di Aristippo, del poeta Callimaco. La Cirenaica, del resto, era la terra in cui il mito poneva il Giardino delle Esperidi e per gli italiani ciò rinvigoriva il sogno di un Africa settentrionale fertile, dalla prodigiosa vegetazione esotica, dal clima mite, dai frutti ricchi. In realtà di quel passato leggendario restavano i resti grigio-plumbei di Tolmeita, l’antica Tolemaide, di Berenice, ovvero Bengasi, di Apollonia, cioè di Marsa Susa, e Arsinoe, della stessa Cirene, le città che costituivano la Pentapoli cirenaica.
Si avviarono nuovi scavi ma l’enorme sviluppo economico non fu turistico, fu industriale. Bengasi divenne a tutti gli effetti una città moderna con un nuovo aeroporto, una nuova stazione ferroviaria, una stazione idrovolante, un porto ampliato e molte strutture.
A Bengasi sorsero impianti per la lavorazione del sale, la raffinazione del petrolio, la trasformazione alimentare, la produzione di cemento e la concia delle pelli. Nei pressi del porto fu creato un moderno ospedale e, non lontano, un nuovo aeroporto.
I più importanti progetti infrastrutturali nella Cirenaica italiana, oltre all’ampliamento del porto di Bengasi, risollevato da un profondo declino, furono la costruzione della strada costiera tra Tripoli e Bengasi, le ferrovie Bengasi-Barce e Bengasi-Soluch. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale furono interrotti i lavori che avrebbero collegato Bengasi anche Tripoli con una tratta ferroviaria.
Autore articolo: Angelo D’Ambra
Bibliografia: Ministero degli Affari Esteri. L’Italia in Africa