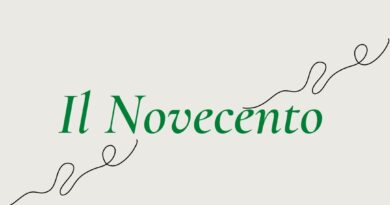Diritto e storia delle repubbliche marinare di Ancona, Gaeta, Noli e Ragusa. Intervista ad Alfonso Mignone
L’avvocato Alfonso Mignone, esperto in diritto della navigazione e dei trasporti, autore del recente “Porto di Salerno. Una storia lunga dieci secoli“, concentra parte della sua attenzione sulla storia del diritto marittimo. Lo ringraziamo per averci concesso questa intervista sulle repubbliche marinare di Ancona, Gaeta, Noli e Ragusa.
***
Poco note sono le vicende delle Repubbliche Marinare di Ancona, Gaeta, Noli e Ragusa ma esse rivestono grande interesse storico soprattutto per quel che riguarda i codici marittimi. Cosa può dirci in merito?
Vorrei premettere innanzitutto che il termine “Repubblica Marinara” è stato coniato dalla storicistica ottocentesca ma, giuridicamente, è improprio in quanto, così come nelle quattro più conosciute, il potere era gestito da una figura che accentrava i poteri ed era molto più vicina ad un monarca.
Gaeta, dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la “reconquista” bizantina divenne, come Amalfi, Napoli e Sorrento, un ducato indipendente nell’875, anno in cui sotto l’ipata Marino I iniziò a coniare una propria moneta: il “follaro”.Questo avvenimento dotò la città di un’indipendenza di fatto e, unitamente alla libertà di navigazione ed al fiorente commercio marittimo, la rese importante centro costiero del Tirreno Centrale che visse alterne fortune trafficando con l’Oriente. Gaeta fu tale fino al 1140 quando il ducato fu annesso al Regno di Sicilia. Fino alla stesura della parte dedicata alla navigazione marittima negli Statuti del 1356, raccolti nel Codex Diplomaticus Cajetanus, il ducato non ebbe propria regolamentazione in materia ma ricorse all’applicazione di consuetudini formate da una miscellanea di diritto rodio-romano e bizantino come il Nomos Rhodion Nautikos.
Noli, per via dell’abilità dei suoi mercanti e dei suoi naviganti, ebbe una propria flotta, autonoma e molto efficiente, che le garantì, anche per via della partecipazione alle Crociate, di divenire una media potenza economica. Grazie a questo periodo di prosperità, riuscì, nel corso del 1192, a divenire, subito dopo Genova e Savona, Comune libero ed indipendente retto da propri consoli. Nel campo legislativo si diede propri Statuti divisi in quattro libri (diritto pubblico, civile, penale e amministrativo) mentre per il diritto marittimo applicò la normativa della vicina Genova, di cui fu sempre fedele alleata fino al 1797.
Ad Ancona vigettero gli Statuti anconitani del mare, del terzenale e della dogana, redatti nel 1387. I primi sono un vero e proprio Corpus iuris maritimi diviso in ottantasei rubriche che trattano dei vari tipi di navi, del loro armamento, degli ufficiali di bordo, delle norme per il trasporto di passeggeri, del carico e dello scarico delle merci e delle pene per i trasgressori. Gli Statuti del Terzenale riguardavano invece le attività del cantiere navale (terzenale significa infatti “arsenale” ). Gli Statuti della Dogana normavano invece l’attività di importazione ed esportazione delle merci e sono divisi in centosessanta rubriche. Anche ad Ancona era stabilito che tutte le controversie relative alla navigazione dovevano essere discusse in un tribunale apposito, chiamato Consolato del mare. Nella città dorica possiamo riconoscere l’influenza della legislazione marittima bizantina nonché del Consolato del mare di Barcellona del XIV secolo, della legislazione marittima veneziana (lo Statuto del doge Zeno), ragusea (il Liber Statutorum) e di Trani (gli Ordinamenta maris).
Per quel che concerne infine Ragusa, odierna Dubrovnik, fu, dopo Venezia, la maggiore potenza navale dell’adriatico dal X secolo al 1808. La legislazione dello Stato raguseo fu adottata sotto la spinta decisiva di Marco Giustiniani di Venezia, onorevole conte di Ragusa, e contenuta nel Liber Statutorum del 1272, composto in otto libri di cui gli ultimi due vanno a disciplinare il diritto marittimo che ha chiare influenze bizantine e veneziane. Successivamente furono varati l’Ordo super assecuratoribus (Regolamento per le assicurazioni marittime) nel 1568 e i Regolamenti della Repubblica di Ragusa per la navigazione nazionale nel 1745.
Cosa prevedevano i codici per quanto concerne l’amministrazione della giustizia marittima?
L’amministrazione della giustizia marittima fu chiaramente un tratto peculiare delle città marinare. Sull’esempio delle quattro “Repubbliche Marinare” più note, la magistratura che aveva il compito di giudicare sulle controversie legate ai traffici era il Consolato del mare da non confondere con il Consolat de Mar, il principale testo di norme consuetudinarie di diritto marittimo dell’alto Medioevo, redatto a Barcellona nella seconda metà del sec. XIV che costituì, fino al sec. XVIII, la normativa comune per il bacino del Mediterraneo.
Solitamente tali magistrati avevano giurisdizione in primo grado sulle cause fra padroni di navi e mercanti, e in appello su tutte le altre cause marittime e mercantili, poi la tradizione di affidare a giudicanti specializzati in materia è andata scemando con la nascita dello Stato moderno e la codificazione marittima.
Credo che in Italia occorrerebbe recuperare queste tradizioni e creare delle sezioni specializzate per decidere sul contenzioso in materia per rispondere alla crescente domanda di giustizia nei “maritime affairs” anche nel nostro territorio e ciò anche in virtù delle diverse fonti internazionali che trovano applicazione nel nostro Paese ma che, investendo questioni transnazionali e a contenuto tecnico, raramente possono essere gestite con la dovuta perizia da parte del giudice interno anche in virtù del mancato inserimento del diritto della navigazione tra le discipline oggetto della preparazione al concorso in Magistratura. Tale aspetto mi sembra paradossale in un Paese a vocazione marittima come il nostro.
Qual è l’eredità di questi codici nel moderno diritto marittimo?
In realtà non possiamo definirli “codici” perché la codificazione del diritto marittimo avvenne solo con la nascita dello Stato Moderno e la legge divenne espressione della volontà del sovrano. Intanto nel Mezzogiorno durante il predominio della potenza spagnola tra il XIV ed il XVI secolo si affermò il Consolato del Mare di Barcellona che mantenne inalterate alcune costumanze dell’Alto Medioevo, soprattutto in materia di contratti di utilizzo della nave, e confermò il ruolo dei Consoli quali giudici delle controversie marittime. A Ponente, Noli seguì le sorti di Genova applicando le leggi marittime dei vari Statuti della Superba. Ancona fece invece parte dello Stato Pontificio allineandosi alle sue leggi. Ragusa mantenne sempre i suoi Statuti fino alla fine della sua indipendenza nel 1808.
Tentativi successivi di compilazione (o meglio raccolte di consuetudini a cui si darà forza di legge) ci furono, a Ponente, con il Codice Sardo della Navigazione, a cui lavorò il giurista sassarese Domenico Azuni, e quello della Veneta Marina Mercantile, a Levante. A Sud restò incompiuto il tentativo di Ferdinando IV di promulgare il Codice Marittimo del Regno di Napoli affidato al giurista procidano Michele De Jorio.
Dopo l’Unità d’Italia, si superò tutto con l’emanazione dei Codici della Marina Mercantile di fine Ottocento e del Codice della Navigazione del 1942.Possiamo in linea di massima concludere come non sia opportuno parlare di influenza degli Statuti medievali sulla codificazione moderna perchè essa ha preso totalmente il posto della consuetudine che dall’ “internazionalismo” romano si era tramutata in differenti, anche se similari, tradizioni giuridiche a carattere locale.
Le repubbliche di Ancona, Gaeta, Noli e Ragusa fin dove estesero i propri commerci ed a cosa si deve la loro fine?
I traffici commerciali di Gaeta risalgono al periodo romano e, con l’indipendenza da Bisanzio, si intensificano nel medioevo, grazie al rapporto privilegiato con il Papato, anche se in concorrenza con Amalfi, Napoli e Salerno fino al periodo della dominazione normanna, quando la città perse di nuovo la sua centralità. L’esportazione, soprattutto di olio d’oliva, avveniva con i porti del Nord Africa e del Vicino Oriente.
Di Noli si è già detto che le sue fortune commerciali furono in gran parte dovute agli stretti rapporti intessuti con Genova ma era la pesca l’attività proponderante della piccola cittadina ligure.
Ancona, anche se limitata dalla leadership di Venezia nell’Adriatico, riuscì, grazie ai rapporti molto stretti con Ragusa, a ritagliarsi una via commerciale, alternativa a quella veneziana, verso il Medio Oriente: la città inviava in quelle terre i suoi consoli ed aveva fondachi e colonie. A Costantinopoli, per esempio, vi era il suo fondaco forse più importante e gli anconetani avevano una propria chiesa, Santo Stefano, e, inoltre, nel 1261, venne loro accordato il privilegio d’avere una cappella nella basilica di Santa Sofia. Altri fondachi anconitani erano in Siria (a Laiazzo e a Laodicea), in Romania (a Costanza), in Egitto (ad Alessandria), a Cipro (a Famagosta), in Palestina (a San Giovanni d’Acri), in Grecia (a Chio), in Asia Minore (a Trebisonda). Spostandosi verso occidente, fondachi anconitani erano presenti nell’Adriatico a Ragusa e a Segna, in Sicilia a Siracusa e a Messina, in Spagna a Barcellona e a Valenza, in Africa a Tripoli.
Anche Ragusa dovette fare i conti con Venezia ma le principali famiglie nobili della città si videro accordare privilegi nel commercio marittimo e in particolare il diritto di importare verso la laguna veneta il legname e i metalli necessari per la costruzione delle navi. Questi commercianti spinsero i propri concittadini, dopo un periodo passato sotto la protezione dell’Imperatore di Bisanzio, ad accettare il protettorato della Serenissima con molti vantaggi militari e commerciali.
Il tramonto di queste piccoli Stati a vocazione mercantile avvenne in tempi e modalità diverse. Gaeta mantenne una certa indipendenza, nonostante le forti influenze bizantine prima e longobarde poi, sino al 1140, quando il Ducato fu conquistato da Ruggero II, ma dal suo porto continuarono a salpare navi per la Barberia e l’Oriente; Noli seguì le sorti di Genova e nel 1797 inevitabilmente fu sottomessa a Napoleone Bonaparte, divenendo parte della Repubblica Ligure; Ancona, occupata dalle truppe pontificie di Clemente VII, perse la sua indipendenza ed il suo privilegio di porta d’Oriente dell’Italia centrale nel 1532; più longeva fu senza dubbio Ragusa che si arrese ai francesi nel 1806 e nel 1808, fu sciolta definitivamente entrando a far parte del bonapartiano Regno Italico.