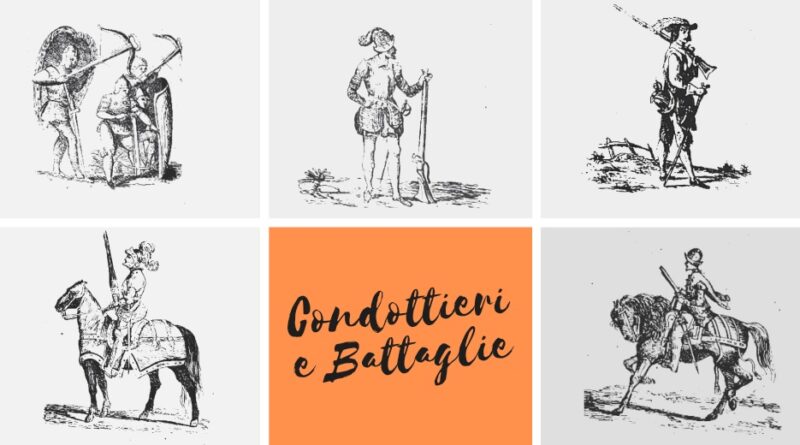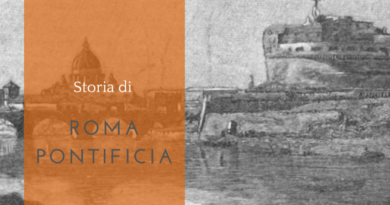Cesena e il massacro dei bretoni
Furono più di tremila i cesenati ammazzati dall’armata di Roberto di Ginevra, futuro antipapa Clemente VII, al servizio di Papa Gregorio XI durante la Guerra degli Otto Santi.
La condotta politica che la corte pontificia ad Avignone tenne per quanto concerne l’Italia era fortemente orientata a ridurre la potenza dei grandi casati del Nord, anzitutto quello dei Visconti, ed a conservare integro lo Stato Pontificio affidandosi a legati, quasi sempre francesi, ed a soldatesche mercenarie. Il tema del predominio francese sulla chiesa era molto sentito. Il trasferimento della Curia Romana l’aveva liberata dall’impasse delle diatribe locali e delle lotte intestine tra le potenti famiglie che avevano imposto i papi precedenti, come i Colonna e gli Orsini, ma l’aveva asservita al re di Francia. Da Clemente V, eletto nel 1305, tutti i papi erano stati francesi e, nel 1377, su 29 cardinali, ben 24 erano quelli francesi. In concreto, poi, il ruolo dei rettori si sostanziava nell’imporre sottomissione, donativi, balzelli, tasse che confluivano in Francia con disapprovazione delle città italiane, cui si era aggiunto il blocco delle esportazioni di grano per fronteggiare le ricorrenti carestie del centro Italia.
La Repubblica di Firenze, che intendeva così bloccare l’eventuale espansione pontificia nei territori della Lunigiana che Gregorio XI aveva richiesto, apparentemente ed invano, come condizione per il suo ritorno a Roma, raccolse le lagnanze dei domini pontifici e scoppiò la rivolta. Furono scacciati i rettori papalini e distrutte fortezze, città, castelli, soggette al dominio papale, tranne quelle che reggevano i Malatesta, Signori di Rimini. Parliamo della Guerra degli Otto Santi, un conflitto tra i meno indagati della storia d’Italia che fu così chiamato in riferimento agli otto consiglieri fiorentini che furono deputati alla guida della coalizione di Firenze, Siena, Lucca, Arezzo e Pisa contro lo Stato romano. La lega contro Gregorio XI si rafforzò dell’appoggio di Bernabò Visconti, Signore di Milano, e Giovanna d’Angiò, la Regina di Napoli, così molti storici vi lessero i tratti di una vera e propria sollevazione nazionale contro la dominazione francese.
Il pontefice, sconvolto dalle notizie che gli portavano i rettori scacciati dall’Italia, s’accinse a programmare un rapido ritorno a Roma, temendo che potesse insorgere anch’essa. Gregorio XI, sordo ai consigli di suo padre, il Conte di Beaufort, del Re di Francia e del Duca d’ Angiò, suo fratello, il 13 settembre del 1373 lasciò Avignone per giungere Marsiglia. Il mare tempestoso disperse le sue galee che giunsero sulle coste laziali il 5 dicembre. Il pontefice poté entrare a Roma solo il 17 gennaio del 1377.
S’era però fatto precedere dal Cardinale Roberto di Ginevra coi suoi 6000 cavalieri e 4000 fanti, per lo più bretoni e guasconi come Jean Malestroit e Sylvestre de Budes, che avevano servito nell’esercito d’Enrico di Trastamara durante la Guerra di Castiglia.
Giunto in Vaticano, il primo pensiero di Gregorio XI fu quello di riconquistare le città ribelli e punire Bologna che aveva cacciato il cardinale Guglielmo di Noellet, così il Roberto di Ginevra si portò sotto le mura della città romagnola e ne minacciò i cittadini accompagnando quelle parole dure con promesse di clemenza, ma le porte restarono chiuse. Intanto i dintorni di Bologna si tingevano di sangue: Olevato e Monteveglio, che si erano arresi ai bretoni, furono dati alle fiamme ed i loro abitanti trapassati a fil di spada. Bologna invece sembrava inconquistabile, era ben provvista di vettovaglie e protetta dalle truppe inviatele anzitempo da Firenze, circa duemila fanti e seimila cavalieri guidati da Rodolfo da Varano. Il cardinale allora tentò impadronirsi della città servendosi di un tradimento, ma i congiurati, scoperti, vennero messi a morte. Alla fine la abbandonò e si diresse in Toscana.
Trovò fortificate e munite di truppe tutte le gole e gli sbocchi degli Appennini e dovette allora portarsi a Cesena per trascorrere lì il vicino inverno. Questa città era sotto la signoria di Galeotto Malatesta, fedele al pontefice, dunque l’armata del cardinale vi prese alloggio senza problemi.
La Rocca della Murata fu concessa ai bretoni che però, insofferenti ad ogni disciplina e bramosi di razzie e battaglie, scatenarono presto la loro ferocia sui cittadini inermi, saccheggiando le loro case e violentando le donne senza che il cardinale riuscisse a placarle.
La pazienza dei cesenati durò poco. L’1 di febbraio del 1577 i cittadini di Cesena si scatenarono inaspettatamente contro i bretoni trucidandoli di contrada in contrada. Oltre trecento ne furono contati morti e gli altri dovettero rinchiudersi nella Rocca della Murata. I cesenati furono calmati da Galeotto Malatesta ma il Cardinale Roberto di Ginevra fece accorrere, da Faenza, le milizie di John Hawkwood che colsero la cittadinanza nel sonno scatenando, con i bretoni, un orrendo massacro che durò tre giorni e tre notti.
A quel tempo Cesena, all’interno delle mura, aveva circa 8000 abitanti. Ne furono trucidati 5000 e i restanti fuggirono lasciando la città deserta. Roberto di Ginevra s’era guadagnato il titolo di “macellator caesenatum”.
Quando la cosa si seppe, tutta l’Italia ne fu inorridita. Firenze, l’8 febbraio, denunciò l’atrocità commessa dal cardinale inviando una lettera alle città alleate di Perugia, Arezzo, Fermo, Ascoli e Siena, oltre che al re di Francia e ad altri regnanti europei, per informarli dell’accaduto, ribadendo la responsabilità del cardinale, ma senza frutto. Le città della Toscana e dello Stato Pontificio, in guerra con Gregorio XI, chiusero i magazzini in segno di lutto e celebrarono messe per i defunti. I brettoni si intrattennero a Cesena sino all’estate quando il Malatesta si impegnò a ricostruire la città ed a farla ripopolare.
Autore articolo: Angelo D’Ambra